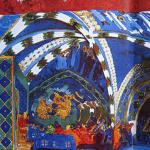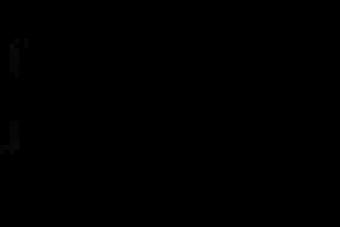da franceseélite: selezionata, selezionata, migliore alta cultura, i cui consumatori sono persone educate , si distingue per un altissimo grado di specializzazione, pensato, per così dire, ad “uso interno” e spesso teso a complicarne il linguaggio, cioè a renderlo inaccessibile ai più. ? Una sottocultura di gruppi privilegiati della società, caratterizzata da chiusura fondamentale, aristocrazia spirituale e autosufficienza semantico-valore. Facendo appello a una minoranza selezionata dei suoi soggetti, che, di regola, ne sono sia i creatori che i destinatari (in ogni caso, il cerchio di entrambi quasi coincide), E.K. si oppone consapevolmente e coerentemente alla cultura della maggioranza, o alla cultura di massa in senso lato (in tutte le sue varietà storiche e tipologiche - folklore, cultura popolare, cultura ufficiale di una particolare classe o classe, lo stato nel suo insieme, l'industria culturale di società tecnocratica -va XX secolo, ecc.) (vedi Cultura di massa). Inoltre, E.k. necessita di un contesto costante di cultura di massa, poiché si basa sul meccanismo di repulsione dai valori e dalle norme accettati nella cultura di massa, sulla distruzione degli stereotipi e dei modelli esistenti della cultura di massa (compresa la loro parodia, ridicolo, ironia, grottesco , polemica, critica, confutazione), sull’autoisolamento dimostrativo in generale nazionale cultura. A questo proposito, E.k. - un fenomeno tipicamente marginale all'interno di ogni storia. o nazionale tipo di cultura ed è sempre secondario, derivato rispetto alla cultura della maggioranza. Il problema di E.K. è particolarmente acuto. in comunità dove l’antinomia tra cultura di massa ed E.K. praticamente esaurisce tutta la varietà delle manifestazioni del nazionalismo. cultura nel suo insieme e dove si trova l’area mediativa (“centrale”) del nazionale cultura, una parte costitutiva di essa. corpo e ugualmente opposto alle culture polarizzate di massa e E. come estremi valore-semantici. Ciò è tipico, in particolare, delle culture che hanno una struttura binaria e sono inclini a forme di inversione della storia. sviluppo (culture russe e tipologicamente simili). L'irrigazione varia. e le élite culturali; il primo, detto anche “regnante”, “potente”, oggi, grazie ai lavori di V. Pareto, G. Mosca, R. Michels, C.R. Mills, R. Miliband, J. Scott, J. Perry, D. Bell e altri sociologi e scienziati politici sono stati studiati in modo sufficientemente dettagliato e approfondito. Molto meno studiate sono le élite culturali, strati uniti da principi non economici, sociali e politici. e interessi e obiettivi di potere reali, ma anche principi ideologici, valori spirituali, norme socioculturali, ecc. Collegati in linea di principio da meccanismi simili (isomorfi) di selezione, consumo di status, prestigio, élite politica. e quelli culturali, però, non coincidono tra loro e solo talvolta stringono alleanze temporanee, che risultano estremamente instabili e fragili. Basti ricordare i drammi spirituali di Socrate, condannato a morte dai suoi concittadini, e di Platone, disilluso dal tiranno siracusano Dionigi (il Vecchio), che si impegnò a mettere in pratica l'utopia platonica dello “Stato”, Pushkin, che si rifiutò di “servire il re, servire il popolo” e quindi riconobbe l’inevitabilità della sua creatività. solitudine, sebbene reale a modo suo ("Sei un re: vivi da solo"), e L. Tolstoj, che, nonostante la sua origine e posizione, cercò di esprimere l '"idea popolare" attraverso i mezzi della sua arte alta e unica del linguaggio, europeo. educazione, sofisticata filosofia e religione dell'autore. Vale qui la pena ricordare la breve fioritura delle scienze e delle arti alla corte di Lorenzo il Magnifico; l'esperienza del massimo mecenatismo di Luigi XIV alle muse, che diede al mondo esempi dell'Europa occidentale. classicismo; un breve periodo di cooperazione tra la nobiltà illuminata e la burocrazia nobiliare durante il regno di Caterina II; unione pre-rivoluzionaria di breve durata. russo. intellighenzia con il potere bolscevico negli anni '20. e così via. , al fine di affermare la natura multidirezionale e in gran parte mutuamente esclusiva delle élite politiche e culturali interagenti, che racchiudono rispettivamente le strutture semantico-sociali e semantiche-culturali della società e coesistono nel tempo e nello spazio. Ciò significa che E.k. non è una creazione o un prodotto dell'acqua. élite (come è stato spesso affermato negli studi marxisti) e non ha carattere partitico di classe, ma in molti casi si sviluppa nella lotta contro la politica. élite per la loro indipendenza e libertà. Al contrario, è logico supporre che siano le élite culturali a contribuire alla formazione della politica. élite (strutturalmente isomorfe alle élite culturali) in una sfera più ristretta di stato socio-politico. e le relazioni di potere come caso speciale, isolato e alienato dall'intero E.K. A differenza della politica. Le élite, le élite spirituali e creative sviluppano i propri meccanismi fondamentalmente nuovi di autoregolamentazione e criteri semantici di valore per la scelta attiva che vanno oltre il quadro strettamente sociale e politico. richieste, e spesso accompagnate da un allontanamento dimostrativo dalla politica e istituzioni sociali e l'opposizione semantica a questi fenomeni come extraculturali (antiestetici, immorali, non spirituali, intellettualmente poveri e volgari). In E.k. La gamma di valori riconosciuti come veri e “alti” è deliberatamente limitata e il sistema di norme accettate da un dato strato come obblighi viene inasprito. e rigoroso nella comunicazione degli “iniziati”. Quantità Il restringimento dell'élite e della sua unità spirituale è inevitabilmente accompagnato dalle sue qualità. crescita (in termini intellettuali, estetici, religiosi, etici e di altro tipo) e quindi individualizzazione di norme, valori, criteri di valutazione dell'attività, spesso principi e forme di comportamento dei membri della comunità d'élite, diventando così unici. In realtà, per questo motivo, il circolo di norme e valori di E.K. diventa decisamente alto, innovativo, ciò che può essere ottenuto in vari modi. significa: 1) padroneggiare nuove realtà sociali e mentali come fenomeni culturali o, al contrario, rifiuto di qualsiasi cosa nuova e “protezione” di una ristretta cerchia di valori e norme conservatrici; 2) inserimento del proprio soggetto in un contesto valore-semantico inaspettato, che rende la sua interpretazione unica e addirittura esclusiva. Senso; 3) la creazione di una nuova semantica culturale deliberatamente complicata (metaforica, associativa, allusiva, simbolica e metasimbolica), che richiede una conoscenza speciale da parte del destinatario. preparazione e vasti orizzonti culturali; 4) lo sviluppo di uno speciale linguaggio culturale (codice), accessibile solo a una ristretta cerchia di intenditori e progettato per complicare la comunicazione, per erigere barriere semantiche insormontabili (o molto difficili da superare) al pensiero profano, che risulta essere, in principio, incapace di comprendere adeguatamente le innovazioni di E.K., di “decifrarne” i significati; 5) l'uso di un'interpretazione deliberatamente soggettiva, individualmente creativa, “defamiliarizzante” dell'ordinario e del familiare, che avvicina l'assimilazione culturale della realtà da parte del soggetto a un esperimento mentale (a volte artistico) su di essa e, all'estremo, sostituisce la riflessione della realtà in E.K. la sua trasformazione, imitazione - deformazione, penetrazione nel significato - congettura e ripensamento del dato. Per la sua “chiusura”, “ristrettezza”, isolamento semantico e funzionale dall'intero nazionale. cultura, E.k. spesso si trasforma in una tipologia (o somiglianza) di segreto, sacro, esoterico. conoscenza che è tabù per il resto delle masse, e i suoi portatori si trasformano in una sorta di “sacerdoti” di questa conoscenza, prescelti dagli dei, “servitori delle muse”, “custodi dei segreti e della fede”, che spesso è interpretato e poeticizzato in E.K. Storico origine dell'E.c. esattamente questo: già nella società primitiva, sacerdoti, magi, stregoni, capi tribù diventano detentori privilegiati di conoscenze speciali, che non possono e non devono essere destinate ad un uso generale, di massa. Successivamente, questo tipo di rapporto tra E.k. e la cultura di massa in una forma o nell'altra, in particolare secolare, furono ripetutamente riprodotte (nelle varie confessioni religiose e soprattutto nelle sette, negli ordini cavallereschi monastici e spirituali, nelle logge massoniche, nelle botteghe artigiane che coltivavano le competenze professionali, nelle riunioni religiose e filosofiche, negli ambienti letterari, artistici e intellettuali formatisi attorno a un leader carismatico, nelle associazioni scientifiche e nelle scuole scientifiche, nelle associazioni e nei partiti politici - compresi soprattutto quelli che operavano in modo cospiratorio, cospiratorio, clandestino, ecc.). In definitiva, l’elitarismo di conoscenze, abilità, valori, norme, principi e tradizioni che si è formato in questo modo è stata la chiave per una professionalità sofisticata e una profonda specializzazione tematica, senza la quale la storia sarebbe impossibile nella cultura. progresso, progresso crescita semantica del valore, contenere. arricchimento e accumulo di perfezione formale: qualsiasi gerarchia semantica di valori. E.k. agisce come un principio di iniziativa e produttivo in qualsiasi cultura, eseguendo principalmente lavori creativi. funzione in esso; mentre la cultura di massa stereotipa, routinizza e profana i risultati di E.K., adattandoli alla percezione e al consumo della maggioranza socioculturale della società. A sua volta, E.k. ridicolizza o denuncia costantemente la cultura di massa, la parodia o la deforma in modo grottesco, presentando il mondo della società di massa e la sua cultura come spaventoso e brutto, aggressivo e crudele; in questo contesto, il destino dei rappresentanti di E.K. raffigurato come tragico, svantaggiato, distrutto (concetti romantici e post-romantici di “genio e folla”; “follia creativa” o “malattia sacra” e ordinario “buon senso”; ispirata “ebbrezza”, incluso narcotico, e volgare “sobrietà”; “celebrazione della vita” e noiosa quotidianità). Teoria e pratica di E.k. fiorisce in modo particolarmente produttivo e fruttuoso alla “rottura” delle epoche culturali, con il cambiamento culturale e storico. paradigmi, che esprimono in modo univoco le condizioni di crisi della cultura, l'equilibrio instabile tra “vecchio” e “nuovo”, i rappresentanti di E.K. realizzarono la loro missione nella cultura come “iniziatori del nuovo”, in anticipo sui tempi, come creatori non compresi dai loro contemporanei (come, ad esempio, erano la maggior parte dei romantici e dei modernisti - simbolisti, figure culturali dell'avanguardia e prof. rivoluzionari che hanno portato avanti la rivoluzione culturale). Ciò include anche i “principianti” di tradizioni su larga scala e i creatori dei paradigmi del “grande stile” (Shakespeare, Goethe, Schiller, Pushkin, Gogol, Dostoevskij, Gorkij, Kafka, ecc.). Questa opinione, per quanto giusta sotto molti aspetti, non era tuttavia l’unica possibile. Quindi, per motivi russi. culturale (dove l'atteggiamento pubblico nei confronti di E.K. era nella maggior parte dei casi diffidente o addirittura ostile, il che non ha nemmeno contribuito alla relativa diffusione di E.K., rispetto all'Europa occidentale), sono nati concetti che interpretano E.K. come un allontanamento conservatore dalla realtà sociale e dai suoi problemi urgenti nel mondo dell’estetica idealizzata (“arte pura” o “arte per l’arte”), della religione. e mitolo. fantasie, socio-politiche. utopista, filosofo idealismo, ecc. (defunto Belinsky, Chernyshevsky, Dobrolyubov, M. Antonovich, N. Mikhailovsky, V. Stasov, P. Tkachev e altri pensatori democratici radicali). Nella stessa tradizione, Pisarev e Plekhanov, così come Ap. Grigoriev ha interpretato E.k. (inclusa “l’arte per l’arte”) come forma dimostrativa di rifiuto sociale e politico. realtà, come espressione di protesta nascosta e passiva contro di essa, come rifiuto di partecipare alla società. lotta del suo tempo, vedendo in questo una storia caratteristica. sintomo (crisi profonda) e marcata inferiorità dell'E.K. stesso. (mancanza di ampiezza e lungimiranza storica, debolezza sociale e impotenza ad influenzare il corso della storia e la vita delle masse). Teorici di E.k - Platone e Agostino, Schopenhauer e Nietzsche, Vl. Soloviev e Leontiev, Berdyaev e A. Bely, Ortega y Gasset e Benjamin, Husserl e Heidegger, Mannheim ed Ellul - variarono variamente la tesi sull'ostilità della democratizzazione e sulla massificazione della cultura e delle sue qualità. livello, il suo contenuto e la perfezione formale, creativo. ricerca intellettuale, estetica, religiosa. e altre novità, sullo stereotipo e sulla banalità che inevitabilmente accompagna la cultura di massa (idee, immagini, teorie, trame), sulla mancanza di spiritualità e sulla violazione della creatività. personalità e la soppressione della sua libertà nelle condizioni della società e della meccanica di massa. replicazione dei valori spirituali, espansione della produzione industriale della cultura. Questa tendenza è quella di approfondire le contraddizioni tra E.K. e la massa - sono aumentate senza precedenti nel 20° secolo. e ha ispirato molte storie toccanti e drammatiche. collisioni (cfr., ad esempio, i romanzi: “Ulisse” di Joyce, “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust, “ Lupo della steppa" e "Il gioco delle perle di vetro" di Hesse, "La montagna incantata" e "Dottor Faustus" di T. Mann, "Noi" di Zamyatin, "La vita di Klim Samgin" di Gorky, "Il maestro e Margherita" di Bulgakov , "The Pit" e "Chevengur" di Platonov, "Pyramid" di L. Leonov e altri). Allo stesso tempo, nella storia culturale del XX secolo. Ci sono molti esempi che illustrano chiaramente la dialettica paradossale di E.K. e massa: la loro reciproca transizione e reciproca trasformazione, la reciproca influenza e l'autonegazione di ciascuno di essi. Quindi, ad esempio, creativo. ricerca di vari rappresentanti della cultura moderna (simbolisti e impressionisti, espressionisti e futuristi, surrealisti e dadaisti, ecc.) - artisti, teorici del movimento, filosofi e pubblicisti - miravano a creare campioni unici e interi sistemi di E.C. Molti dei perfezionamenti formali erano sperimentali; teoria manifesti e dichiarazioni confermavano il diritto dell'artista e del pensatore ad essere creativi. incomprensibilità, separazione dalle masse, dai loro gusti e bisogni, fino all’esistenza intrinseca della “cultura per la cultura”. Tuttavia, poiché il campo di attività in espansione dei modernisti comprendeva oggetti quotidiani, situazioni quotidiane, forme di pensiero quotidiano, strutture di comportamento generalmente accettate, storia attuale. eventi, ecc. (anche se con un segno “meno”, come “tecnica meno”), il modernismo ha cominciato – involontariamente, e poi consapevolmente – a fare appello alle masse e alla coscienza di massa. Scioccante e beffardo, grottesco e denuncia della persona media, slapstick e farsa: questi sono gli stessi generi, dispositivi stilistici ed espressioni legittimi. media della cultura di massa, oltre a giocare sui cliché e sugli stereotipi della coscienza di massa, manifesti e propaganda, farse e stornelli, recitazione e retorica. La stilizzazione o parodia della banalità è quasi indistinguibile da quella stilizzata e parodiata (ad eccezione della distanza ironica dell'autore e del contesto semantico generale, che rimangono quasi sfuggenti alla percezione di massa); ma il riconoscimento e la familiarità della volgarità rendono la sua critica - altamente intellettuale, sottile, estetizzata - poco comprensibile ed efficace per la maggior parte dei destinatari (che non sono in grado di distinguere il ridicolo di gusto di basso livello dall'indulgere ad esso). Di conseguenza, acquisisce la stessa opera culturale doppia vita con diversi contenuto semantico e pathos ideologico opposto: da un lato risulta essere indirizzato a E.K., dall'altro alla cultura di massa. Queste sono molte opere di Cechov e Gorkij, Mahler e Stravinsky, Modigliani e Picasso, L. Andreev e Verhaeren, Mayakovsky ed Eluard, Meyerhold e Shostakovich, Yesenin e Kharms, Brecht e Fellini, Brodsky e Voinovich. La contaminazione da CE è particolarmente controversa. e la cultura di massa nella cultura postmoderna; ad esempio, in un fenomeno così precoce del postmodernismo come la Pop Art, c'è un'elitarizzazione della cultura di massa e allo stesso tempo una massificazione dell'elitarismo, che ha dato origine ai classici moderni. il postmodernista W. Eco caratterizza la pop art come “lowbrow highbrow” o, al contrario, come “highbrow lowbrow” (in inglese: Lowbrow Highbrow o Highbrow Lowbrow). Non meno paradossi sorgono quando si comprende la genesi della cultura totalitaria (vedi Cultura totalitaria), che, per definizione, è una cultura di massa e una cultura delle masse. Tuttavia, nella sua origine, la cultura totalitaria affonda le sue radici proprio in E.K.: ad esempio Nietzsche, Spengler, Weininger, Sombart, Jünger, K. Schmitt e altri filosofi e politici socio-politici. pensatori che anticiparono e avvicinarono i tedeschi al potere reale. Il nazismo apparteneva sicuramente a E.K. e in molti casi sono stati fraintesi e distorti dalla loro pratica. interpreti, primitivizzati, semplificati secondo uno schema rigido e una demagogia semplice. La situazione è simile con i comunisti. totalitarismo: i fondatori del marxismo - Marx ed Engels, e Plekhanov, e lo stesso Lenin, e Trotsky, e Bukharin - erano tutti, a modo loro, intellettuali "intellettuali" e rappresentavano una cerchia molto ristretta di intellighenzia dalla mentalità radicale. Inoltre, l'ideale. L'atmosfera dei circoli socialdemocratici, socialisti e marxisti, allora cellule del partito strettamente cospiratorie, fu costruita in pieno accordo con i principi di E.K. (esteso solo alla cultura politica ed educativa), e il principio di appartenenza al partito implicava non solo selettività, ma anche una selezione piuttosto rigorosa di valori, norme, principi, concetti, tipi di comportamento, ecc. In realtà, il meccanismo stesso selezione(su basi razziali e nazionali o su basi politiche di classe), che sta alla base del totalitarismo come sistema socio-culturale, è stato creato da E.K., nel suo profondo, dai suoi rappresentanti, e successivamente solo estrapolato alla società di massa, in cui tutto ciò che è ritenuto opportuno viene riprodotto e intensificato, e tutto ciò che è pericoloso per la sua autoconservazione e il suo sviluppo è proibito e confiscato (anche con la violenza). Pertanto, la cultura totalitaria nasce inizialmente dall'atmosfera e dallo stile, dalle norme e dai valori del circolo d'élite, viene universalizzata come una sorta di panacea, e poi viene imposta con la forza alla società nel suo insieme come modello ideale e viene praticamente introdotto nella coscienza e nelle società di massa. attività con qualsiasi mezzo, compresi quelli non culturali. In condizioni di sviluppo post-totalitario, così come nel contesto occidentale democrazia, i fenomeni della cultura totalitaria (emblemi e simboli, idee e immagini, concetti e stile del realismo socialista), presentati in modo culturalmente pluralistico. contesto e distanziato dai tempi moderni. la riflessione – puramente intellettuale o estetica – comincia a funzionare come esotica. Componenti E.C e sono percepiti da una generazione che ha familiarità con il totalitarismo solo attraverso fotografie e aneddoti, "stranamente", grottescamente, associativamente. Le componenti della cultura di massa incluse nel contesto di E.K. agiscono come elementi di E.K.; mentre le componenti di E.K., inscritte nel contesto della cultura di massa, diventano componenti della cultura di massa. Nel paradigma culturale postmoderno, i componenti di E.k. e la cultura di massa sono usate allo stesso modo come materiale di gioco ambivalente, e il confine semantico tra massa ed E.K. risulta fondamentalmente offuscato o rimosso; in questo caso, la distinzione tra E.k. e la cultura di massa perde praticamente il suo significato (conservando per il potenziale destinatario solo il significato allusivo del contesto genetico-culturale). Illuminato.: Mills R. L'élite dominante. M., 1959; Ashin G.K. Il mito delle élite e “ società di massa" M., 1966; Davydov Yu.N. Arte ed élite. M., 1966; Davidyuk GP, BC Bobrovsky. Problemi di “cultura di massa” e di “comunicazioni di massa”. Minsk, 1972; Snow Ch. Due culture. M., 1973; “Cultura di massa”: illusioni e realtà. Sab. Arte. M., 1975; Ashin G.K. Critica dei tempi moderni borghese concetti di leadership. M., 1978; Kartseva E.N. Fondamenti ideologici ed estetici della “cultura di massa” borghese. M., 1976; Narta M. Teoria delle élite e della politica. M., 1978; Raynov B. "Cultura di massa". M., 1979; Shestakov V.P. “L'arte della banalizzazione”: alcuni problemi della “cultura di massa” // VF. 1982. N. 10; Gershkovich Z.I. Paradossi della “cultura di massa” e moderna lotta ideologica. M., 1983; Molchanov V.V. Miraggi della cultura di massa. L., 1984; Tipi e forme d'arte di massa. M., 1985; Ashin G.K. Moderno teorie d'élite: critiche. articolo in mostra. M., 1985; Kukarkin A.V. Cultura di massa borghese. M., 1985; Smolskaya E.P. “Cultura di massa”: intrattenimento o politica? M., 1986; Shestakov V. Mitologia del 20 ° secolo. M., 1988; Isupov K. G. Estetica russa della storia. San Pietroburgo, 1992; Dmitrieva N.K., Moiseeva A.P. Filosofa dello spirito libero (Nikolai Berdyaev: vita e creatività). M., 1993; Ovchinnikov V.F. Persona creativa nel contesto della cultura russa. Kaliningrad, 1994; Fenomenologia dell'arte. M., 1996; Elite e massa nella cultura artistica russa. Sab.st. M., 1996; Zimovets S. Il silenzio di Gerasim: saggi psicoanalitici e filosofici sulla cultura russa. M., 1996; Afanasyev M.N. Elite dominanti e statualità nella Russia post-totalitaria (corso di lezioni). M.; Voronež, 1996; Dobrenko E. Stampaggio del lettore sovietico. Sociale ed estetico. prerequisiti per la ricezione della letteratura sovietica. San Pietroburgo, 1997; Soffietto R. Leadership creativa. Prentice-Hall, 1959; Packard V. I cercatori di status. New York, 1963; Weyl N. L'élite creativa in America. Washington, 1966; Spitz D. Modelli di pensiero antidemocratico. Glencoe, 1965; Jodi M. Teorie elità un problema elità. Praga, 1968; Parry G. Elite politica. L, 1969; RubinJ. Fallo! New York, 1970; Prewitt K., Stone A. Le élite dominanti. Teoria delle élite, potere e democrazia americana. New York, 1973; Gans H.G. Cultura popolare e cultura alta. New York, 1974; Swingwood A. Il mito della cultura di massa. L., 1977; Toffler A. La terza ondata. New York, 1981; Ridless R. Ideologia e arte. Teorie della cultura di massa da W. Benjamin a U. Eco. New York, 1984; Shiah M. Discorso sulla cultura popolare. Stanford, 1989; Teoria, Cultura e Società. L., 1990. I. V. Kondakov. Studi culturali del Novecento. Enciclopedia. M.1996
In contatto con
Compagne di classe
I concetti di massa e cultura d'élite definire due tipi di cultura nella società moderna, che sono associati alle peculiarità del modo in cui la cultura esiste nella società: i metodi della sua produzione, riproduzione e diffusione nella società, la posizione che la cultura occupa nella struttura sociale della società, l'atteggiamento di cultura e i suoi creatori Vita di ogni giorno persone e problemi socio-politici della società. La cultura d'élite appare prima della cultura di massa, ma nella società moderna coesistono e interagiscono in modo complesso.
Cultura di massa
Definizione del concetto
Nella letteratura scientifica moderna esistono varie definizioni di cultura di massa. Alcuni associano la cultura di massa allo sviluppo nel XX secolo di nuovi sistemi di comunicazione e riproduzione (stampa di massa ed editoria di libri, registrazione audio e video, radio e televisione, xerografia, telex e telefax, comunicazioni satellitari, tecnologia informatica) e allo scambio globale di informazioni che è sorto grazie ai risultati ottenuti rivoluzione scientifica e tecnologica. Altre definizioni di cultura di massa sottolineano la sua connessione con lo sviluppo di un nuovo tipo struttura sociale società industriale e postindustriale, che portò alla creazione di un nuovo modo di organizzare la produzione e la trasmissione della cultura. La seconda comprensione della cultura di massa è più completa e comprensiva, perché non solo include le mutate basi tecniche e tecnologiche della creatività culturale, ma considera anche il contesto socio-storico e le tendenze nelle trasformazioni culturali della società moderna.
Cultura popolare Questo è un tipo di prodotto che viene prodotto in grandi quantità ogni giorno. Questo è un insieme di fenomeni culturali del 20 ° secolo e caratteristiche della produzione valori culturali nella moderna società industriale, progettata per il consumo di massa. In altre parole, si tratta di una produzione a nastro trasportatore attraverso vari canali, compresi i mezzi mass-media e comunicazioni.
Si presuppone che la cultura di massa sia consumata da tutte le persone, indipendentemente dal luogo e dal paese di residenza. Questa è la cultura della vita quotidiana, presentata sui canali più ampi possibili, compresa la TV.
L'emergere della cultura di massa
Relativamente prerequisiti per l’emergere della cultura di massa Ci sono diversi punti di vista:
- La cultura di massa è nata agli albori della civiltà cristiana. Ad esempio, vengono citate versioni semplificate della Bibbia (per bambini, per poveri) destinate a un pubblico di massa.
- Nei secoli XVII-XVIII, nell'Europa occidentale apparve il genere del romanzo d'avventura, che ampliò significativamente il numero di lettori grazie alle enormi diffusioni. (Esempio: Daniel Defoe - il romanzo “Robinson Crusoe” e altre 481 biografie di persone che svolgono professioni rischiose: investigatori, militari, ladri, prostitute, ecc.).
- Nel 1870 in Gran Bretagna fu approvata una legge sull'alfabetizzazione universale, che permise a molti di padroneggiare la principale forma d'arte. creatività XIX secolo - romanzo. Ma questa è solo la preistoria della cultura di massa. In senso proprio, la cultura di massa si manifestò per la prima volta negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
L'emergere della cultura di massa è associato alla massificazione della vita a cavallo tra Ottocento e Novecento. In questo momento, il ruolo delle masse umane è aumentato in vari ambiti della vita: economia, politica, gestione e comunicazione tra le persone. Ortega y Gaset definisce così il concetto di massa:
La messa è una folla. Una folla in termini quantitativi e visivi è una moltitudine, e una moltitudine da un punto di vista sociologico è una massa. La massa è la persona media. La società è sempre stata un’unità mobile della minoranza e delle masse. Una minoranza è un insieme di persone particolarmente individuate; la massa è un gruppo di persone che non viene in alcun modo individuato. Ortega vede la ragione della promozione delle masse in prima linea nella storia nella bassa qualità della cultura, quando una persona di una determinata cultura “non differisce dagli altri e ripete il tipo generale”.
Includono anche i prerequisiti per la cultura di massa l'emergere di un sistema di comunicazioni di massa durante la formazione della società borghese(stampa, editoria di massa, poi radio, televisione, cinema) e lo sviluppo dei trasporti, che permisero di ridurre lo spazio e il tempo necessari alla trasmissione e alla diffusione dei valori culturali nella società. La cultura emerge dall’esistenza locale e inizia a funzionare su scala globale. Nazione stato(emerge una cultura nazionale, superando le restrizioni etniche), e poi entra nel sistema di comunicazione interetnica.
I prerequisiti per la cultura di massa includono anche la creazione all'interno della società borghese di una struttura speciale di istituzioni per la produzione e la diffusione dei valori culturali:
- Aspetto istituzioni pubbliche istruzione (scuole secondarie, scuole professionali, istituti di istruzione superiore);
- Creazione di istituzioni produttrici di conoscenza scientifica;
- L'emergere dell'arte professionale (accademie arti visive, teatro, opera, balletto, conservatorio, riviste letterarie, case editrici e associazioni, mostre, musei pubblici, gallerie espositive, biblioteche), che videro anche la nascita dell'istituto critica d'arte come mezzo per divulgare e sviluppare le sue opere.
Caratteristiche e significato della cultura di massa
La cultura di massa nella sua forma più concentrata si manifesta nella cultura artistica, così come nelle sfere del tempo libero, della comunicazione, del management e dell'economia. Il termine "cultura di massa" fu introdotto per la prima volta dal professore tedesco M. Horkheimer nel 1941 e dallo scienziato americano D. MacDonald nel 1944. Il contenuto di questo termine è abbastanza contraddittorio. Da un lato, la cultura di massa - "cultura per tutti", d'altra parte, questo è "non proprio cultura". La definizione di cultura di massa sottolinea diffusionela vulnerabilità e l'accessibilità generale dei valori spirituali, nonché la facilità della loro assimilazione, che non richiede gusto e percezione particolarmente sviluppati.
L'esistenza della cultura di massa si basa sulle attività dei media, le cosiddette arti tecniche (cinema, televisione, video). La cultura di massa esiste non solo nei sistemi sociali democratici, ma anche nei regimi totalitari, dove tutti sono un “ingranaggio” e tutti sono uguali.
Attualmente alcuni ricercatori abbandonano la visione della “cultura di massa” come un’area di “cattivo gusto” e non la considerano anticulturale. Molte persone si rendono conto che la cultura di massa non ha solo caratteristiche negative. Influisce:
- la capacità delle persone di adattarsi alle condizioni di un'economia di mercato;
- rispondere adeguatamente a improvvisi cambiamenti sociali situazionali.
Oltretutto, la cultura di massa è capace:
- compensare la mancanza di comunicazione personale e l'insoddisfazione per la vita;
- aumentare il coinvolgimento della popolazione negli eventi politici;
- aumentare la stabilità psicologica della popolazione in situazioni sociali difficili;
- rendere accessibili a molti le conquiste della scienza e della tecnologia.
Dovrebbe essere riconosciuto che la cultura di massa è un indicatore oggettivo dello stato della società, delle sue idee sbagliate, delle forme tipiche di comportamento, degli stereotipi culturali e del sistema di valori reali.
Nella sfera della cultura artistica, invita una persona a non ribellarsi al sistema sociale, ma ad inserirsi in esso, a trovare e prendere il suo posto in una società industriale di tipo mercato.
A conseguenze negative della cultura di massa si riferisce alla sua capacità di mitizzare coscienza umana, per mistificare i processi reali che si verificano nella natura e nella società. C'è un rifiuto del principio razionale nella coscienza.
C'erano una volta bellissime immagini poetiche. Hanno parlato della ricchezza dell'immaginazione di persone che non potevano ancora comprendere e spiegare correttamente l'azione delle forze della natura. Oggi i miti sono al servizio della povertà del pensiero.
Da un lato, si potrebbe pensare che lo scopo della cultura di massa sia alleviare la tensione e lo stress in una persona in una società industriale - dopotutto, è divertente. Ma in realtà, questa cultura non riempie tanto il tempo libero quanto stimola la coscienza consumistica dello spettatore, dell'ascoltatore e del lettore. Un tipo di percezione passiva e acritica di questa cultura sorge in una persona. E se così fosse, viene creata una personalità, la cui coscienza facile mammamanipolare, le cui emozioni sono facili da indirizzare a destralato.
In altre parole, la cultura di massa sfrutta gli istinti della sfera subconscia dei sentimenti umani e, soprattutto, i sentimenti di solitudine, senso di colpa, ostilità, paura, autoconservazione.
Nella pratica della cultura di massa, la coscienza di massa ha mezzi di espressione specifici. La cultura di massa è più focalizzata non su immagini realistiche, ma su immagini create artificialmente: immagini e stereotipi.
La cultura popolare crea una formula di eroe, immagine ripetitiva, stereotipo. Questa situazione crea idolatria. Viene creato un “Olimpo” artificiale, gli dei sono “stelle” e sorge una folla di ammiratori e ammiratori fanatici. A questo proposito, la cultura artistica di massa incarna con successo il mito umano più desiderabile: mito di un mondo felice. Allo stesso tempo, non chiama il suo ascoltatore, spettatore, lettore a costruire un mondo del genere: il suo compito è offrire a una persona rifugio dalla realtà.
Le origini della diffusione capillare della cultura di massa nel mondo moderno risiedono nella natura commerciale di tutto relazioni pubbliche. Il concetto di “prodotto” definisce l’intera diversità delle relazioni sociali nella società.
Attività spirituale: cinema, libri, musica, ecc., in connessione con lo sviluppo dei mass media, diventano una merce nelle condizioni della produzione a catena di montaggio. L'attitudine commerciale viene trasferita nella sfera della cultura artistica. E questo determina il carattere divertente delle opere d'arte. È necessario che la clip ripaga, i soldi spesi per la produzione del film producono un profitto.
La cultura di massa forma uno strato sociale nella società, chiamato “ classe media» . Questa classe divenne il fulcro della vita nella società industriale. Un moderno rappresentante della “classe media” è caratterizzato da:
- Lottare per il successo. Realizzazione e successo sono i valori verso cui è orientata la cultura in una tale società. Non è un caso che le storie su come qualcuno sia fuggito dal povero al ricco, da una povera famiglia di emigranti a una "stella" ben pagata della cultura di massa siano così popolari in esso.
- La seconda caratteristica distintiva di una persona della “classe media” è possesso di proprietà privata . Un'auto prestigiosa, un castello in Inghilterra, una casa sulla Costa Azzurra, un appartamento a Monaco... Di conseguenza, i rapporti tra le persone vengono sostituiti da rapporti di capitale, di reddito, cioè sono impersonalmente formali. Una persona deve essere in costante tensione, sopravvivere in condizioni di feroce concorrenza. E sopravvivono i più forti, cioè coloro che riescono nella ricerca del profitto.
- Il terzo valore caratteristico di una persona della “classe media” è individualismo . Questo è il riconoscimento dei diritti individuali, della sua libertà e indipendenza dalla società e dallo Stato. L'energia di una personalità libera è diretta nella sfera dell'attività economica e politica. Ciò contribuisce allo sviluppo accelerato delle forze produttive. L’uguaglianza è possibile Stey, competizione, successo personale - da un lato, questo è un bene. Ma, d'altra parte, ciò porta a una contraddizione tra gli ideali di una personalità libera e la realtà. In altre parole, come principio del rapporto tra uomo e uomo l’individualismo è disumano, e come norma del rapporto di una persona con la società - antisociale .
Nell'arte e nella creatività artistica, la cultura di massa svolge le seguenti funzioni sociali:
- introduce una persona nel mondo dell'esperienza illusoria e dei sogni irrealistici;
- promuove lo stile di vita dominante;
- distrae le grandi masse delle persone dall’attività sociale e le costringe ad adattarsi.
Da qui l'uso nell'arte di generi come detective, western, melodramma, musical, fumetti, pubblicità, ecc.
Cultura d'élite
Definizione del concetto
La cultura d'élite (dall'élite francese - selezionata, migliore) può essere definita come una sottocultura di gruppi privilegiati della società(mentre a volte il loro unico privilegio può essere il diritto alla creatività culturale o alla conservazione eredità culturale), che è caratterizzato da isolamento valore-semantico, chiusura; la cultura d'élite si afferma come la creatività di una ristretta cerchia di “massimi professionisti”, la cui comprensione è accessibile a una cerchia altrettanto ristretta di intenditori altamente istruiti. La cultura d’élite pretende di stare al di sopra dell’“ordinarietà” della vita quotidiana e di occupare la posizione di “tribunale supremo” in relazione ai problemi socio-politici della società.
La cultura d'élite è considerata da molti culturologi l'antitesi della cultura di massa. Da questo punto di vista, il produttore e consumatore di beni culturali d’élite costituisce lo strato più alto e privilegiato della società. elite . Negli studi culturali moderni è stata stabilita la comprensione dell'élite come uno strato speciale della società dotato di specifiche capacità spirituali.
L’élite non è solo lo strato più alto della società, l’élite dominante. In ogni classe sociale esiste una élite.
Elite- questa è la parte della società più capaceattività spirituale, dotata di alta morale e inclinazioni estetiche. È lei che garantisce il progresso sociale, quindi l'arte dovrebbe concentrarsi sulla soddisfazione delle sue richieste e bisogni. Gli elementi principali del concetto elitario di cultura sono contenuti in opere filosofiche A. Schopenhauer (“Il mondo come volontà e idea”) e F. Nietzsche (“Umano, troppo umano”, “La gaia scienza”, “Così parlò Zarathustra”).
A. Schopenhauer divide l'umanità in due parti: "persone di genio" e "persone di beneficio". I primi sono capaci di contemplazione estetica e di attività artistica, i secondi si concentrano solo su attività puramente pratiche e utilitaristiche.
La demarcazione tra cultura d'élite e cultura di massa è associata allo sviluppo delle città, alla stampa di libri e all'emergere di un cliente e di un artista nella sfera. Elite - per intenditori sofisticati, massa - per il lettore, lo spettatore, l'ascoltatore ordinario e ordinario. Le opere che servono come standard dell'arte di massa, di regola, rivelano una connessione con costruzioni folcloristiche, mitologiche e popolari che esistevano prima. Nel XX secolo, il concetto elitario di cultura è stato riassunto da Ortega y Gaset. L’opera di questo filosofo spagnolo, “La disumanizzazione dell’arte”, sostiene che la nuova arte è indirizzata all’élite della società e non alle sue masse. Pertanto, l'arte non deve necessariamente essere popolare, generalmente comprensibile, universale. La nuova arte dovrebbe allontanare le persone vita reale. "Disumanizzazione" - ed è la base della nuova arte del XX secolo. Ci sono classi polari nella società - maggioranza (massa) e minoranza (élite) . La nuova arte, secondo Ortega, divide il pubblico in due classi: quelli che la capiscono e quelli che non la capiscono, cioè gli artisti e quelli che artisti non sono.
Elite , secondo Ortega, non si tratta dell'aristocrazia tribale e non degli strati privilegiati della società, ma di quella parte di essa che ha uno “speciale organo di percezione” . È questa parte che contribuisce progresso sociale. Ed è proprio a questo che gli artisti dovrebbero rivolgersi con le loro opere. La nuova arte dovrebbe contribuire a garantire che “...i migliori conoscano se stessi, imparino a comprendere il proprio scopo: essere in minoranza e lottare con la maggioranza”.
Una tipica manifestazione della cultura d'élite è teoria e pratica dell’“arte pura” o dell’“arte per l’arte” , che ha trovato la sua incarnazione nella cultura dell'Europa occidentale e russa a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ad esempio, in Russia, le idee della cultura d'élite sono state sviluppate attivamente dall'associazione artistica “World of Art” (artista A. Benois, editore della rivista S. Diaghilev, ecc.).
L’emergere di una cultura d’élite
La cultura d'élite, di regola, nasce in epoche di crisi culturale, il crollo delle vecchie e la nascita di nuove tradizioni culturali, metodi di produzione e riproduzione dei valori spirituali e un cambiamento nei paradigmi culturali e storici. Pertanto, i rappresentanti della cultura d'élite si percepiscono come "creatori del nuovo", che sovrastano il loro tempo, e quindi non compresi dai loro contemporanei (si tratta principalmente di romantici e modernisti - figure dell'avanguardia artistica, che fanno una rivoluzione culturale ), o “custodi dei fondamenti fondamentali”, che dovrebbero essere protetti dalla distruzione e il cui significato non è compreso dalle “masse”.
In una situazione del genere, la cultura d'élite acquisisce caratteristiche dell'esoterismo- conoscenza chiusa e nascosta, che non è destinata ad un uso ampio e universale. Nella storia, i portatori di varie forme di cultura d'élite sono stati sacerdoti, sette religiose, ordini cavallereschi monastici e spirituali, logge massoniche, corporazioni artigianali, circoli letterari, artistici e intellettuali e organizzazioni clandestine. Si verifica un tale restringimento dei potenziali destinatari della creatività culturale consapevolezza della propria creatività come eccezionale: “vera religione”, “scienza pura”, “arte pura” o “arte per l’arte”.
Il concetto di “élite” in contrapposizione a “massa” fu introdotto alla fine del XVIII secolo. La divisione della creatività artistica in élite e massa si è manifestata nei concetti dei romantici. Inizialmente, tra i romantici, l'elitario porta in sé il significato semantico di essere scelto ed esemplare. Il concetto di esemplare, a sua volta, era inteso come identico a quello classico. Il concetto di classico è stato sviluppato in modo particolarmente attivo. Quindi il nucleo normativo era l'arte dell'antichità. In questa comprensione, il classico era personificato con l'elitario e l'esemplare.
I romantici hanno cercato di concentrarsi innovazione nel campo della creatività artistica. Pertanto, hanno separato la loro arte dalle solite forme d'arte adattate. La triade: “elite - esemplare - classico” cominciò a sgretolarsi: l'elitario non era più identico al classico.
Caratteristiche e significato della cultura d'élite
Una caratteristica della cultura d'élite è l'interesse dei suoi rappresentanti nella creazione di nuove forme, un'opposizione dimostrativa a forme armoniose arte classica, così come un'enfasi sulla soggettività della visione del mondo.
I tratti caratteristici di una cultura d’élite sono:
- il desiderio di sviluppo culturale di oggetti (fenomeni del mondo naturale e sociale, realtà spirituali), che si distinguono nettamente dalla totalità di ciò che è compreso nell'ambito dello sviluppo soggettivo della cultura “ordinaria”, “profana” di un tempo a disposizione;
- inclusione del proprio soggetto in contesti valore-semantici inaspettati, creazione della sua nuova interpretazione, significato unico o esclusivo;
- la creazione di un nuovo linguaggio culturale (linguaggio dei simboli, delle immagini), accessibile a una ristretta cerchia di intenditori, la cui decodificazione richiede sforzi speciali e un'ampia visione culturale da parte dei non iniziati.
La cultura d’élite è di natura duplice e contraddittoria. Da un lato, la cultura d’élite agisce come un enzima innovativo del processo socioculturale. Le opere della cultura d'élite contribuiscono al rinnovamento della cultura della società, introducendovi nuove questioni, linguaggi e metodi di creatività culturale. Inizialmente, entro i confini della cultura d'élite, nascono nuovi generi e tipi di arte, si sviluppa il linguaggio culturale e letterario della società e straordinari teorie scientifiche, concetti filosofici e insegnamenti religiosi, che sembrano “irrompere” oltre i confini stabiliti della cultura, ma poi possono diventare parte del patrimonio culturale dell'intera società. Ecco perché, ad esempio, si dice che la verità nasce come eresia e muore come banalità.
D'altro canto, la posizione di una cultura d'élite, che si oppone alla cultura della società, può significare un allontanamento conservatore dalla realtà sociale e dai suoi problemi pressanti per entrare nel mondo idealizzato dell'"arte per l'arte", religioso, filosofico e socio-culturale. utopie politiche. Una tale forma dimostrativa di rifiuto del mondo esistente può essere sia una forma di protesta passiva contro di esso, sia una forma di riconciliazione con esso, il riconoscimento dell’impotenza della cultura d’élite, della sua incapacità di influenzare vita culturale società.
Questa dualità della cultura d'élite determina anche la presenza di teorie opposte - critiche e apologetiche - della cultura d'élite. I pensatori democratici (Belinsky, Chernyshevsky, Pisarev, Plekhanov, Morris, ecc.) erano critici nei confronti della cultura elitaria, sottolineando la sua separazione dalla vita della gente, la sua incomprensibilità per la gente, il suo servire i bisogni delle persone ricche e stanche. Inoltre, tale critica a volte andava oltre i limiti della ragione, trasformandosi, ad esempio, dalla critica dell'arte d'élite alla critica di tutta l'arte. Pisarev, ad esempio, ha dichiarato che “gli stivali sono più alti dell’arte”. L. Tolstoj, che creò alti esempi del romanzo della New Age ("Guerra e pace", "Anna Karenina", "Domenica"), nell'ultimo periodo del suo lavoro, quando passò alla posizione della democrazia contadina, considerò tutte queste opere inutili per il popolo e cominciò a comporre storie popolari della vita contadina.
Un'altra direzione delle teorie della cultura d'élite (Schopenhauer, Nietzsche, Berdyaev, Ortega y Gasset, Heidegger ed Ellul) la difese, sottolineandone il significato, la perfezione formale, la ricerca creativa e la novità, il desiderio di resistere agli stereotipi e alla mancanza di spiritualità della cultura quotidiana , e lo considerava un rifugio di libertà personale creativa.
Una varietà di arte d'élite del nostro tempo è il modernismo e il postmodernismo.
Riferimenti:
1. Afonin V. A., Afonin Yu. V. Teoria e storia della cultura. Un libro di testo per il lavoro indipendente degli studenti. – Lugansk: Elton-2, 2008. – 296 pag.
2.Studi culturali in domande e risposte. Una guida metodologica per la preparazione ai test e agli esami nel corso “Cultura ucraina e straniera” per studenti di tutte le specialità e forme di studio. / Rappresentante. Editore Ragozin N.P. - Donetsk, 2008, - 170 p.
Cultura d'élite
La cultura d'élite o alta è creata da una parte privilegiata della società o, su sua richiesta, da creatori professionisti. Include belle Arti, musica classica e letteratura. La cultura alta, ad esempio la pittura di Picasso o la musica di Schnittke, è difficile da comprendere per una persona impreparata. Di norma, è decenni avanti rispetto al livello di percezione di una persona mediamente istruita. La cerchia dei suoi consumatori è una parte altamente istruita della società: critici, studiosi di letteratura, frequentatori di musei e mostre, spettatori di teatro, artisti, scrittori, musicisti. Quando il livello di istruzione della popolazione aumenta, la cerchia dei consumatori di alta cultura si allarga. Le sue varietà includono arte secolare e musica da salotto. La formula della cultura d’élite è “arte per l’arte”.
La cultura d'élite è destinata a una cerchia ristretta di pubblico altamente istruito e si oppone sia alla cultura popolare che a quella di massa. Di solito è incomprensibile al grande pubblico e richiede una buona preparazione per una corretta percezione.
La cultura d’élite comprende movimenti d’avanguardia nella musica, nella pittura, nel cinema, letteratura complessa natura filosofica. Spesso i creatori di tale cultura sono percepiti come abitanti di una “torre d'avorio”, separati con la loro arte dalla vita quotidiana reale. Di norma, la cultura d'élite non è commerciale, anche se a volte può avere successo finanziario e passare alla categoria della cultura di massa.
Le tendenze moderne sono tali che la cultura di massa penetra in tutte le aree della “cultura alta”, mescolandosi con essa. Allo stesso tempo, la cultura di massa riduce il livello culturale generale dei suoi consumatori, ma allo stesso tempo essa stessa sale gradualmente a un livello culturale più elevato. Sfortunatamente, il primo processo è ancora molto più intenso del secondo.
Oggi, un posto sempre più importante nel sistema comunicazione interculturale occupano meccanismi di diffusione dei prodotti culturali. La società moderna vive in una civiltà tecnica, che si distingue fondamentalmente per metodi, mezzi, tecnologie e canali per la trasmissione delle informazioni culturali. Pertanto, nel nuovo spazio informativo e culturale, sopravvive solo ciò che è richiesto di massa, e solo i prodotti standardizzati della cultura di massa in generale e della cultura d'élite in particolare hanno questa proprietà.
La cultura d’élite è una combinazione conquiste creative società umana, la cui creazione e adeguata percezione richiede una formazione speciale. L'essenza di questa cultura è associata al concetto di élite come produttore e consumatore della cultura d'élite. In relazione alla società, questo tipo di cultura è il più alto, privilegiato per strati, gruppi, classi speciali della popolazione che svolgono le funzioni di produzione, gestione e sviluppo della cultura. Pertanto, la struttura della cultura è divisa in pubblica ed élite.
La cultura d'élite è stata creata per preservare il pathos e creatività. Il concetto più coerente e olistico di cultura d'élite si riflette nelle opere di J. Ortega y Gasset, secondo il quale l'élite è una parte della società dotata di inclinazioni estetiche e morali e più capace di produrre attività spirituale. Pertanto, scienziati, artisti, scrittori e filosofi di grande talento e abilità sono considerati l'élite. I gruppi d’élite possono essere relativamente autonomi dagli strati economici e politici, oppure possono compenetrarsi a vicenda in determinate situazioni.
La cultura d'élite è piuttosto diversificata nei suoi metodi di manifestazione e contenuto. L'essenza e le caratteristiche della cultura d'élite possono essere esaminate usando l'esempio dell'arte d'élite, che si sviluppa principalmente in due forme: panestetismo e isolazionismo estetico.
La forma del panestetismo eleva l’arte al di sopra della scienza, della moralità e della politica. Tali forme artistiche e intuitive di conoscenza portano con sé l’obiettivo messianico di “salvare il mondo”. I concetti di idee panestetiche sono espressi negli studi di A. Bergson, F. Nietzsche, F. Schlegel.
Una forma di isolazionismo estetico si sforza di esprimere “arte per l’arte” o “arte pura”. Il concetto di questa idea si basa sul sostegno della libertà di auto-esibizione e di auto-espressione individuale nell'arte. Secondo i fondatori dell’isolazionismo estetico, il mondo moderno è privo di bellezza, che è l’unica fonte pura della creatività artistica. Questo concetto è stato implementato nelle attività degli artisti S. Diaghilev, A. Benois, M. Vrubel, V. Serov, K. Korovin. A. Pavlova, F. Chaliapin, M. Fokin hanno raggiunto un'alta vocazione nelle arti musicali e del balletto.
In senso stretto, la cultura d'élite è intesa come una sottocultura che non solo differisce da quella nazionale, ma si oppone anche ad essa, acquisendo chiusura, autosufficienza semantica e isolamento. Si basa sulla formazione delle proprie caratteristiche specifiche: norme, ideali, valori, un sistema di segni e simboli. Pertanto, la sottocultura è progettata per unire determinati valori spirituali di persone che la pensano allo stesso modo, diretti contro la cultura dominante. L'essenza di una sottocultura risiede nella formazione e nello sviluppo delle sue caratteristiche socioculturali, nel loro isolamento da un altro strato culturale.
La cultura d'élite è una cultura alta, in contrasto con la cultura di massa per il tipo di influenza sulla coscienza percettiva, preservandone le caratteristiche soggettive e fornendo una funzione di formazione del significato.
Il soggetto della cultura elitaria e alta è l'individuo: libero, persona creativa capace di svolgere attività cosciente. Le creazioni di questa cultura sono sempre colorate personalmente e progettate per la percezione personale, indipendentemente dall'ampiezza del loro pubblico, motivo per cui l'ampia distribuzione e milioni di copie delle opere di Tolstoj, Dostoevskij e Shakespeare non solo non ne riducono il significato , ma, al contrario, contribuiscono alla diffusione capillare dei valori spirituali. In questo senso, il soggetto della cultura d'élite è un rappresentante dell'élite.
La cultura d’élite ha una serie di caratteristiche importanti.
Caratteristiche della cultura d'élite:
complessità, specializzazione, creatività, innovazione;
la capacità di formare una coscienza pronta per l'attività trasformativa attiva e la creatività in conformità con le leggi oggettive della realtà;
capacità di concentrazione spirituale, intellettuale e esperienza artistica generazioni;
la presenza di un range limitato di valori riconosciuti come veri e “alti”;
un rigido sistema di norme accettate da un dato strato come obbligatorie e rigorose nella comunità degli “iniziati”;
individualizzazione di norme, valori, criteri di valutazione dell'attività, spesso principi e forme di comportamento dei membri della comunità d'élite, diventando così unici;
la creazione di una nuova semantica culturale, volutamente complicata, che richiede il destinatario addestramento speciale e vasti orizzonti culturali;
l'uso di un'interpretazione deliberatamente soggettiva, individualmente creativa, “defamiliarizzante” dell'ordinario e del familiare, che avvicina l'assimilazione culturale della realtà da parte del soggetto a un esperimento mentale (a volte artistico) su di essa e, all'estremo, sostituisce il riflesso della realtà nella cultura d'élite con la sua trasformazione, imitazione con deformazione, penetrazione nel significato - congettura e ripensamento del dato;
“chiusura”, “ristrettezza” semantica e funzionale, isolamento dall'intera cultura nazionale, che trasforma la cultura d'élite in una sorta di conoscenza segreta, sacra, esoterica, e i suoi portatori si trasformano in una sorta di “sacerdoti” di questa conoscenza, scelti quelli degli dei, "servitori delle muse", "custodi dei segreti e della fede", che viene spesso interpretato e poeticizzato nella cultura d'élite.
La cultura d'élite (dall'élite francese - selezionata, selezionata, migliore) è una sottocultura di gruppi privilegiati nella società, caratterizzata da chiusura fondamentale, aristocrazia spirituale e autosufficienza semantica del valore. Facendo appello a una minoranza selezionata dei suoi soggetti, che, di regola, ne sono sia i creatori che i destinatari (in ogni caso, il cerchio di entrambi quasi coincide), E.K. si oppone consapevolmente e coerentemente alla cultura della maggioranza, o alla cultura di massa in senso lato (in tutte le sue varietà storiche e tipologiche - folklore, cultura popolare, cultura ufficiale di una particolare classe o classe, lo stato nel suo insieme, l'industria culturale di società tecnocratica -va XX secolo, ecc.). Inoltre, E.k. necessita di un contesto costante di cultura di massa, poiché si basa sul meccanismo di repulsione dai valori e dalle norme accettati nella cultura di massa, sulla distruzione degli stereotipi e dei modelli esistenti della cultura di massa (compresa la loro parodia, ridicolo, ironia, grottesco , polemica, critica, confutazione), sull’autoisolamento dimostrativo in generale nazionale cultura. A questo proposito, E.k. - un fenomeno tipicamente marginale all'interno di ogni storia. o nazionale tipo di cultura ed è sempre secondario, derivato rispetto alla cultura della maggioranza. Il problema di E.K. è particolarmente acuto. in comunità dove l’antinomia tra cultura di massa ed E.K. praticamente esaurisce tutta la varietà delle manifestazioni del nazionalismo. cultura nel suo insieme e dove si trova l’area mediativa (“centrale”) del nazionale cultura, una parte costitutiva di essa. corpo e ugualmente opposto alle culture polarizzate di massa e E. come estremi valore-semantici. Ciò è tipico, in particolare, delle culture che hanno una struttura binaria e sono inclini a forme di inversione della storia. sviluppo (culture russe e tipologicamente simili).
Le élite politiche e culturali differiscono; il primo, detto anche “regnante”, “potente”, oggi, grazie ai lavori di V. Pareto, G. Mosca, R. Michels, C.R. Mills, R. Miliband, J. Scott, J. Perry, D. Bell e altri sociologi e scienziati politici sono stati studiati in modo sufficientemente dettagliato e approfondito. Molto meno studiate sono le élite culturali – strati uniti non da interessi e obiettivi di potere economico, sociale, politico e reale, ma da principi ideologici, valori spirituali, norme socioculturali, ecc. Collegate in linea di principio da meccanismi simili (isomorfi) di selezione, consumo di status, prestigio, élite politiche e culturali, tuttavia, non coincidono tra loro e solo talvolta stringono alleanze temporanee, che risultano estremamente instabili e fragili. Basti ricordare i drammi spirituali di Socrate, condannato a morte dai suoi concittadini, e di Platone, disilluso dal tiranno siracusano Dionigi (il Vecchio), che si impegnò a mettere in pratica l'utopia platonica dello “Stato”, Pushkin, che rifiutò a “servire il re, servire il popolo” e quindi riconoscere l’inevitabilità della sua creatività. solitudine, sebbene regale a modo suo ("Sei un re: vivi da solo"), e L. Tolstoj, che, nonostante la sua origine e posizione, cercò di esprimere l '"idea popolare" attraverso i mezzi della sua arte alta e unica del linguaggio, europeo. educazione, sofisticata filosofia e religione dell'autore. Vale qui la pena ricordare la breve fioritura delle scienze e delle arti alla corte di Lorenzo il Magnifico; l'esperienza del massimo mecenatismo di Luigi XIV alle muse, che diede al mondo esempi dell'Europa occidentale. classicismo; un breve periodo di cooperazione tra la nobiltà illuminata e la burocrazia nobiliare durante il regno di Caterina II; unione pre-rivoluzionaria di breve durata. russo. intellighenzia con il potere bolscevico negli anni '20. e così via. , al fine di affermare la natura multidirezionale e in gran parte mutuamente esclusiva delle élite politiche e culturali interagenti, che racchiudono rispettivamente le strutture semantico-sociali e semantiche-culturali della società e coesistono nel tempo e nello spazio. Ciò significa che E.k. non è una creazione e un prodotto delle élite politiche (come spesso è stato affermato negli studi marxisti) e non ha natura di partito di classe, ma in molti casi si sviluppa nella lotta contro la politica. élite per la loro indipendenza e libertà. Al contrario, è logico supporre che siano le élite culturali a contribuire alla formazione della politica. élite (strutturalmente isomorfe alle élite culturali) in una sfera socio-politica più ristretta. , stato e le relazioni di potere come caso speciale, isolato e alienato dall'intero E.K.
In contrasto con le élite politiche, le élite spirituali e creative sviluppano propri meccanismi fondamentalmente nuovi di autoregolamentazione e criteri valore-semantici per la scelta attiva, andando oltre il quadro delle effettive esigenze sociali e politiche, e spesso accompagnati da una dimostrazione dimostrativa allontanamento dalla politica e dalle istituzioni sociali e opposizione semantica a questi fenomeni come extraculturali (antiestetici, immorali, non spirituali, intellettualmente poveri e volgari). In E.k. La gamma di valori riconosciuti come veri e “alti” è deliberatamente limitata e il sistema di norme accettate da un dato strato come obblighi viene inasprito. e rigoroso nella comunicazione degli “iniziati”. Le quantità, il restringimento dell'élite e la sua unità spirituale sono inevitabilmente accompagnati dalle sue qualità, dalla sua crescita (intellettuale, estetica, religiosa, etica e altri aspetti) e quindi dall'individualizzazione di norme, valori, criteri di valutazione dell'attività, spesso principi e forme di comportamento dei membri dei messaggi d'élite, diventando così unici.
In realtà, per questo motivo, il circolo di norme e valori di E.K. diventa decisamente alto, innovativo, ciò che può essere ottenuto in vari modi. significa:
1) padroneggiare nuove realtà sociali e mentali come fenomeni culturali o, al contrario, rifiuto di qualsiasi cosa nuova e “protezione” di una ristretta cerchia di valori e norme conservatrici;
2) inclusione del proprio soggetto in un contesto valore-semantico inaspettato, che conferisce alla sua interpretazione un significato unico e perfino esclusivo;
3) la creazione di una nuova semantica culturale deliberatamente complicata (metaforica, associativa, allusiva, simbolica e metasimbolica), che richiede una conoscenza speciale da parte del destinatario. preparazione e vasti orizzonti culturali;
4) lo sviluppo di uno speciale linguaggio culturale (codice), accessibile solo a una ristretta cerchia di intenditori e progettato per complicare la comunicazione, per erigere barriere semantiche insormontabili (o più difficili da superare) al pensiero profano, che risulta essere, in linea di principio, incapace di comprendere adeguatamente le innovazioni di E.K., di “decifrarne” i significati; 5) l'uso di un'interpretazione deliberatamente soggettiva, individualmente creativa, "defamiliarizzante" dell'ordinario e del familiare, che avvicina l'assimilazione culturale della realtà da parte del soggetto a un esperimento mentale (a volte artistico) su di esso e alla fine sostituisce il riflesso della realtà in E.K. la sua trasformazione, imitazione - deformazione, penetrazione nel significato - congettura e ripensamento del dato. Per la sua “chiusura”, “ristrettezza”, isolamento semantico e funzionale dall'intero nazionale. cultura, E.k. spesso si trasforma in una tipologia (o somiglianza) di segreto, sacro, esoterico. conoscenza che è tabù per il resto delle masse, e i suoi portatori si trasformano in una sorta di “sacerdoti” di questa conoscenza, prescelti dagli dei, “servitori delle muse”, “custodi dei segreti e della fede”, che spesso è interpretato e poeticizzato in E.K.
Storico origine dell'E.c. esattamente questo: già nella società primitiva, sacerdoti, magi, stregoni, capi tribù diventano detentori privilegiati di conoscenze speciali, che non possono e non devono essere destinate ad un uso generale, di massa. Successivamente, questo tipo di rapporto tra E.k. e la cultura di massa in una forma o nell'altra, in particolare secolare, furono ripetutamente riprodotte (nelle varie confessioni religiose e soprattutto nelle sette, negli ordini cavallereschi monastici e spirituali, nelle logge massoniche, nelle botteghe artigiane che coltivavano le competenze professionali, nelle riunioni religiose e filosofiche, negli ambienti letterari, artistici e intellettuali formati attorno a un leader carismatico, nelle comunità scientifiche e nelle scuole scientifiche, nelle associazioni politiche e nei partiti - compresi soprattutto quelli che operavano in modo cospiratorio, cospiratorio, clandestino, ecc.). In definitiva, l'elitarismo di conoscenze, abilità, valori, norme, principi, tradizioni che si è formato in questo modo è stata la chiave per una professionalità sofisticata e una profonda conoscenza specializzata specifica per materia, senza la quale la storia sarebbe impossibile nella cultura. progresso, postulato, crescita semantica dei valori, contenimento, arricchimento e accumulazione della perfezione formale - qualsiasi gerarchia semantica dei valori. E.k. agisce come un principio di iniziativa e produttivo in qualsiasi cultura, eseguendo principalmente lavori creativi. funzione in esso; mentre la cultura di massa stereotipa, routinizza e profana i risultati di E.K., adattandoli alla percezione e al consumo della maggioranza socioculturale della società. A sua volta, E.k. ridicolizza o denuncia costantemente la cultura di massa, la parodia o la deforma in modo grottesco, presentando il mondo della società di massa e la sua cultura come spaventoso e brutto, aggressivo e crudele; in questo contesto, il destino dei rappresentanti di E.K. raffigurato come tragico, svantaggiato, distrutto (concetti romantici e post-romantici di “genio e folla”; “follia creativa” o “malattia sacra” e ordinario “buon senso”; ispirata “ebbrezza”, incluso narcotico, e volgare “sobrietà”; “celebrazione della vita” e noiosa quotidianità).
Teoria e pratica di E.k. fiorisce in modo particolarmente produttivo e fruttuoso alla “rottura” delle epoche culturali, con il cambiamento culturale e storico. paradigmi, che esprimono in modo univoco le condizioni di crisi della cultura, l'equilibrio instabile tra “vecchio” e “nuovo”, i rappresentanti degli stessi E.K. realizzarono la loro missione nella cultura come “iniziatori del nuovo”, in anticipo sui tempi, come creatori non compresi dai loro contemporanei (come, ad esempio, erano la maggior parte dei romantici e dei modernisti - simbolisti, figure culturali dell'avanguardia e rivoluzionari di professione che hanno realizzato la rivoluzione culturale). Ciò include anche i “principianti” di tradizioni su larga scala e i creatori dei paradigmi del “grande stile” (Shakespeare, Goethe, Schiller, Pushkin, Gogol, Dostoevskij, Gorkij, Kafka, ecc.). Questa opinione, per quanto giusta sotto molti aspetti, non era tuttavia l’unica possibile. Quindi, per motivi russi. cultura (dove nelle società l'atteggiamento nei confronti di E.K. era nella maggior parte dei casi diffidente o addirittura ostile, il che non ha nemmeno contribuito alla diffusione di E.K., rispetto all'Europa occidentale), sono nati concetti che interpretano E.K. come un allontanamento conservatore dalla realtà sociale e dai suoi problemi urgenti nel mondo dell’estetica idealizzata (“arte pura” o “arte per l’arte”), della religione. e mitolo. fantasie, socio-politiche. utopista, filosofo idealismo, ecc. (defunto Belinsky, Chernyshevsky, Dobrolyubov, M. Antonovich, N. Mikhailovsky, V. Stasov, P. Tkachev e altri, pensatori democratici radicali). Nella stessa tradizione, Pisarev e Plekhanov, così come Ap. Grigoriev ha interpretato E.k. (inclusa “l’arte per l’arte”) come forma dimostrativa di rifiuto della realtà socio-politica, come espressione di protesta nascosta e passiva contro di essa, come rifiuto di partecipare alla società. lotta del suo tempo, vedendo in questo una storia caratteristica. sintomo (crisi profonda) e marcata inferiorità dell'E.K. stesso. (mancanza di ampiezza e lungimiranza storica, società, debolezza e impotenza ad influenzare il corso della storia e la vita delle masse).
Teorici di E.k - Platone e Agostino, Schopenhauer e Nietzsche, Vl. Soloviev e Leontiev, Berdyaev e A. Bely, Ortega y Gasset e Benjamin, Husserl e Heidegger, Mannheim ed Ellul - variarono variamente la tesi sull'ostilità della democratizzazione e sulla massificazione della cultura e delle sue qualità. livello, il suo contenuto e la perfezione formale, creativo. ricerca intellettuale, estetica, religiosa. e altre novità, sullo stereotipo e sulla banalità che inevitabilmente accompagna la cultura di massa (idee, immagini, teorie, trame), sulla mancanza di spiritualità e sulla violazione della creatività. personalità e la soppressione della sua libertà nelle condizioni della società e della meccanica di massa. replicazione dei valori spirituali, espansione della produzione industriale della cultura. Questa tendenza è quella di approfondire le contraddizioni tra E.K. e la massa - sono aumentate senza precedenti nel 20° secolo. e ha ispirato molte storie toccanti e drammatiche. collisioni (cfr. ad esempio i romanzi: “Ulisse” di Joyce, “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust, “Il lupo della steppa” e “Il gioco delle perle” di Hesse, “La montagna incantata” e “Doctor Faustus” di T. Mann, “Noi" Zamiatin, "La vita di Klim Samgin" di Gorky, "Il maestro e Margherita" di Bulgakov, "La fossa" e "Chevengur" di Platonov, "La piramide" di L. Leonov, ecc. .). Allo stesso tempo, nella storia culturale del XX secolo. Ci sono molti esempi che illustrano chiaramente la dialettica paradossale di E.K. e massa: la loro reciproca transizione e reciproca trasformazione, la reciproca influenza e l'autonegazione di ciascuno di essi.
Quindi, ad esempio, creativo. ricerca di vari rappresentanti della cultura moderna (simbolisti e impressionisti, espressionisti e futuristi, surrealisti e dadaisti, ecc.) - artisti, teorici del movimento, filosofi e pubblicisti - miravano a creare campioni unici e interi sistemi di E.C. Molti dei perfezionamenti formali erano sperimentali; teoria manifesti e dichiarazioni confermavano il diritto dell'artista e del pensatore ad essere creativi. incomprensibilità, separazione dalle masse, dai loro gusti e bisogni, fino all’esistenza intrinseca della “cultura per la cultura”. Tuttavia, poiché il campo di attività in espansione dei modernisti comprendeva oggetti quotidiani, situazioni quotidiane, forme di pensiero quotidiano, strutture di comportamento generalmente accettate, storia attuale. eventi, ecc. (anche se con un segno “meno”, come una “tecnica meno”), il modernismo ha iniziato – involontariamente, e poi consapevolmente – a fare appello alle masse e alla coscienza di massa. Scioccante e beffardo, grottesco e denuncia della persona media, slapstick e farsa sono gli stessi generi legittimi, espedienti stilistici ed espressioni, mezzi di cultura di massa, così come giocare sui cliché e sugli stereotipi della coscienza di massa, manifesti e propaganda, farsa e stornelli , recitazione e retorica. La stilizzazione o parodia della banalità è quasi indistinguibile da quella stilizzata e parodiata (ad eccezione della distanza ironica dell'autore e del contesto semantico generale, che rimangono quasi sfuggenti alla percezione di massa); ma il riconoscimento e la familiarità della volgarità rendono la sua critica - altamente intellettuale, sottile, estetizzata - poco comprensibile ed efficace per la maggior parte dei destinatari (che non sono in grado di distinguere il ridicolo di gusto di basso livello dall'indulgere ad esso). Di conseguenza, la stessa opera culturale acquisisce una doppia vita con diverse contenuto semantico e pathos ideologico opposto: da un lato risulta essere indirizzato a E.K., dall'altro alla cultura di massa. Queste sono molte opere di Cechov e Gorkij, Mahler e Stravinsky, Modigliani e Picasso, L. Andreev e Verhaeren, Mayakovsky ed Eluard, Meyerhold e Shostakovich, Yesenin e Kharms, Brecht e Fellini, Brodsky e Voinovich. La contaminazione da CE è particolarmente controversa. e la cultura di massa nella cultura postmoderna; ad esempio, in un fenomeno così precoce del postmodernismo come la pop art, c'è un'elitarizzazione della cultura di massa e allo stesso tempo una massificazione dell'elitarismo, che ha dato origine ai classici dei tempi moderni. Il postmodernista W. Eco caratterizza la pop art come “dalle sopracciglia basse, dalle sopracciglia alte” o, al contrario, come “dalle sopracciglia alte, dalle sopracciglia basse” (in inglese. : Lowbrow Highbrow, o Highbrow Lowbrow).
Non meno paradossi sorgono quando si comprende la genesi della cultura totalitaria, che, per definizione, è una cultura di massa e una cultura delle masse. Tuttavia, nella sua origine, la cultura totalitaria affonda le sue radici proprio in E.K.: ad esempio, Nietzsche, Spengler, Weininger, Sombart, Jünger, K. Schmitt e altri filosofi e pensatori socio-politici che anticiparono e avvicinarono i tedeschi al potere reale. Il nazismo apparteneva sicuramente a E.K. e in molti casi sono stati fraintesi e distorti dalla loro pratica. interpreti, primitivizzati, semplificati secondo uno schema rigido e una demagogia semplice. La situazione è simile con i comunisti. totalitarismo: i fondatori del marxismo - Marx ed Engels, e Plekhanov, e lo stesso Lenin, e Trotsky, e Bukharin - erano tutti, a modo loro, intellettuali "intellettuali" e rappresentavano una cerchia molto ristretta di intellighenzia dalla mentalità radicale. Inoltre, l'ideale. L'atmosfera dei circoli socialdemocratici, socialisti e marxisti, allora cellule del partito strettamente cospiratorie, fu costruita in pieno accordo con i principi di E.K. (esteso solo alla cultura politica e cognitiva), e il principio di appartenenza partitica implicava non solo la selettività, ma anche una selezione piuttosto rigorosa di valori, norme, principi, concetti, tipi di comportamento, ecc. In effetti, il meccanismo stesso di selezione (basato sulla razza e sulla nazionalità) o sulla politica di classe), che sta alla base del totalitarismo come sistema socio-culturale, è stato creato da E.K., nel suo profondo, dai suoi rappresentanti, e successivamente solo estrapolato ad una società di massa , in cui tutto ciò che è riconosciuto come utile viene riprodotto e intensificato, e ciò che è pericoloso per la sua autoconservazione e il suo sviluppo è proibito e sequestrato (anche con la violenza). Pertanto, la cultura totalitaria nasce inizialmente dall'atmosfera e dallo stile, dalle norme e dai valori di un circolo d'élite, viene universalizzata come una sorta di panacea, quindi viene imposta con la forza alla società nel suo insieme come modello ideale e viene praticamente introdotta nella coscienza e nelle società di massa, attività con qualsiasi mezzo, compresi quelli non culturali.
In condizioni di sviluppo post-totalitario, così come nel contesto occidentale democrazia, i fenomeni della cultura totalitaria (emblemi e simboli, idee e immagini, concetti e stile del realismo socialista), presentati in modo culturalmente pluralistico. contesto e distanziato dai tempi moderni. la riflessione – puramente intellettuale o estetica – comincia a funzionare come esotica. Componenti E.C e sono percepiti da una generazione che ha familiarità con il totalitarismo solo attraverso fotografie e aneddoti, "stranamente", grottescamente, associativamente. Le componenti della cultura di massa incluse nel contesto di E.K. agiscono come elementi di E.K.; mentre le componenti di E.K., inscritte nel contesto della cultura di massa, diventano componenti della cultura di massa. Nel paradigma culturale postmoderno, i componenti di E.k. e la cultura di massa sono usate allo stesso modo come materiale di gioco ambivalente, e il confine semantico tra massa ed E.K. risulta fondamentalmente offuscato o rimosso; in questo caso, la distinzione tra E.k. e la cultura di massa perde praticamente il suo significato (conservando per il potenziale destinatario solo il significato allusivo del contesto genetico-culturale).
Il prodotto della cultura d'élite è creato da professionisti e fa parte della società privilegiata che lo ha formato. La cultura di massa fa parte della cultura generale, un indicatore dello sviluppo dell'intera società e non della sua classe individuale.
La cultura d’élite si distingue, la cultura di massa sì grande quantità consumatori.
Comprendere il valore di un prodotto della cultura d'élite richiede determinate competenze e abilità professionali. La cultura di massa è di natura utilitaristica, comprensibile a un’ampia gamma di consumatori.
I creatori di prodotti della cultura d’élite non perseguono il guadagno materiale; sognano solo l’autorealizzazione creativa. I prodotti della cultura di massa portano grandi profitti ai loro creatori.
La cultura di massa semplifica tutto e lo rende accessibile ad ampi settori della società. La cultura d’élite si concentra su una ristretta cerchia di consumatori.
La cultura di massa spersonalizza la società, la cultura elitaria, al contrario, glorifica ciò che è luminoso individualità creativa. Maggiori dettagli: http://thedb.ru/items/Otlichie_elitarnoj_kultury_ot_massovoj/
Letteratura classica
una sfera specifica della creatività culturale associata alla produzione professionale di testi culturali, che successivamente acquisiscono lo status di canoni culturali. Il concetto di "E.K." appare negli studi culturali occidentali per designare strati culturali diametralmente opposti nel contenuto alla cultura di massa “profana”. A differenza delle comunità di conoscenza sacra o esoterica inerenti a qualsiasi tipo di cultura, E.K. rappresenta la sfera della produzione industriale di campioni culturali, esistente in costante interazione con varie forme di cultura di massa, locale e marginale. Allo stesso tempo, per E.K. caratterizzato da un alto grado di chiusura, dovuto sia alle tecnologie specifiche del lavoro intellettuale (che formano una ristretta comunità professionale) sia alla necessità di padroneggiare le tecniche di consumo di prodotti culturali d'élite complessamente organizzati, ad es. un certo livello formazione scolastica. Campioni di E.K. Nel processo di assimilazione implicano la necessità di uno sforzo intellettuale mirato per “decifrare” il messaggio dell’autore. In effetti, E.K. mette il destinatario di un testo d'élite nella posizione di coautore, ricreando nella sua mente un insieme dei suoi significati. A differenza dei prodotti della cultura di massa, i prodotti culturali d’élite sono progettati per un consumo ripetuto e hanno contenuti fondamentalmente ambigui. E.K. stabilisce le linee guida principali per l'attuale tipo di cultura, definendo l'insieme di " giochi mentali", così come un insieme popolare di generi "bassi" e i loro eroi, che riproducono gli archetipi di base dell'inconscio collettivo. Qualsiasi innovazione culturale diventa un evento culturale solo come risultato della sua progettazione concettuale a livello di E.K., includendola in l’attuale contesto culturale e adattandolo alla coscienza di massa Pertanto, lo status di “élite” di specifiche forme di creatività culturale è determinato non tanto dalla loro vicinanza (caratteristica della cultura marginale) quanto dalla complessa organizzazione del prodotto culturale (inerente all’alta cultura) produzione di massa di classe), ma dalla loro capacità di influenzare in modo significativo la vita della società, modellando modi possibili sue dinamiche e creando scenari di azione sociale, orientamenti ideologici, stili artistici e forme di esperienza spirituale adeguati ai bisogni sociali. Solo in questo caso possiamo parlare dell’élite culturale come di una minoranza privilegiata che esprime lo “spirito dei tempi” nella propria creatività.
Contrariamente all'interpretazione romantica di E.K. come “gioco di perle” (Assia) autosufficiente, lontano dal pragmatismo e dalla volgarità della cultura “profana” della maggioranza, il vero status di E.K. molto spesso associato a varie forme di “gioco con il potere”, dialogo servile e/o anticonformista con l’attuale élite politica, nonché alla capacità di lavorare con la “base”, “spazzatura” spazio culturale. Solo in questo caso E.K. conserva la capacità di influenzare il reale stato delle cose nella società.
Concetto elite denota il meglio. Esiste un’élite politica (una parte della società che detiene il potere legittimo), un’élite economica e un’élite scientifica. Il sociologo tedesco G.A. Lansberger definisce l'élite come un gruppo che influenza in modo significativo le decisioni su questioni chiave di natura nazionale. Il segretario generale dell’ONU Dag Hammarskjöld ritiene che l’élite sia quella parte della società in grado di assumersi la responsabilità della maggioranza delle persone. Ortega y Gasset ci credeva elite- Questa è la parte più creativa e produttiva della società, che possiede elevate qualità intellettuali e morali. Nel contesto degli studi culturali, possiamo dire che è nella sfera delle élite che si formano le basi della cultura e i principi del suo funzionamento. Elite- si tratta di uno strato ristretto della società capace di generare nella sua coscienza valori, principi e atteggiamenti attorno ai quali la società può consolidarsi e sulla base dei quali la cultura può funzionare. La cultura d'élite appartiene a uno strato sociale speciale con una ricca esperienza spirituale e una coscienza morale ed estetica sviluppata. Una delle varianti della cultura d'élite è la cultura esoterica. I concetti stessi esoterismo E essoterico disceso da Parole greche esoterikos – interno E exoterikos – esterno. La cultura esoterica è accessibile solo agli iniziati e assorbe conoscenze destinate a una cerchia selezionata di persone. L’essoterismo presuppone popolarità e accessibilità.
L'atteggiamento della società nei confronti della cultura d'élite è ambiguo. Il culturologo Dr. Richard Steitz (USA) identifica 3 tipi di atteggiamenti delle persone nei confronti della cultura d'élite: 1) Statalismo- un gruppo di persone che non sono i creatori della cultura d'élite, ma la apprezzano e la apprezzano. 2) Elitarismo– si considerano una cultura d’élite, ma trattano la cultura di massa con disprezzo. 3) Eclettismo– accettare entrambi i tipi di colture.
Uno dei fattori che aggravarono il bisogno della società ottocentesca di separare la cultura d’élite da quella di massa è associato al ripensamento Religione cristiana, che proponeva quelle norme e principi accettati da tutti i membri della società. Il rifiuto delle norme del cristianesimo significava la perdita di un unico ideale significativo di perfezione assoluta, un criterio assoluto di santità. C’era bisogno di nuovi ideali che potessero stimolare e guidare lo sviluppo sociale. Di fatto, la spaccatura nella mente delle persone riguardo al valore di una comune cultura cristiana ha significato la divisione della società in gruppi sociali, culture, sottoculture, ognuno dei quali ha accettato propri ideali, stereotipi e norme di comportamento. La cultura d'élite, di regola, si oppone alla cultura di massa. Evidenziamo le caratteristiche principali che caratterizzano entrambi i tipi di cultura.
Caratteristiche della cultura d'élite:
1. Costanza, cioè i prodotti della cultura d'élite non dipendono dal tempo e dallo spazio storico. Pertanto, le opere di Mozart dal momento della loro creazione sono esempi di classici in ogni momento e in ogni stato.
2. La necessità del lavoro spirituale. Una persona che vive in un ambiente di cultura d'élite è chiamata a un intenso lavoro spirituale.
3. Requisiti elevati per le competenze umane. In questo caso si intende che non solo il creatore, ma anche il consumatore dei prodotti della cultura d'élite deve essere capace di un intenso lavoro spirituale ed essere sufficientemente preparato in senso storico-artistico.
4. Il desiderio di creare ideali assoluti di perfezione. In una cultura d'élite, le regole dell'onore e lo stato di purezza spirituale acquisiscono un significato centrale e pronunciato.
5. Formazione di quel sistema di valori, di quegli atteggiamenti che servono da fondamento per lo sviluppo della cultura e centro di consolidamento della società.
Caratteristiche della cultura popolare:
1. Possibilità di produzione tramite trasportatore di prodotti legati alle colture.
2. Soddisfare i bisogni spirituali della maggioranza della popolazione.
3. L'opportunità di attrarre molte persone verso la vita sociale e culturale.
4. Riflessione di quei modelli di comportamento, stereotipi e principi che prevalgono nella coscienza pubblica per un dato periodo di tempo.
5. Adempimento degli ordini politici e sociali.
6. Incorporazione nel mondo mentale delle persone di determinati modelli e modelli di comportamento; creazione di ideali sociali.
È importante tenere conto del fatto che in numerosi sistemi culturali il concetto di cultura d'élite è condizionato, poiché in alcune comunità il confine tra l'élite e le masse è minimo. In tali culture è difficile distinguere la cultura di massa dalla cultura d’élite. Molti frammenti della vita quotidiana, ad esempio, ricevono lo status accademico di “fonte” solo se sono lontani da noi nel tempo o hanno un carattere etnografico-folcloristico.
Nel mondo moderno, l’assottigliamento dei confini tra cultura di massa e cultura d’élite è così distruttivo che spesso porta alla svalutazione dei beni culturali per le generazioni successive. Pertanto, la cultura pop ha influenzato tutte le sfere della vita, creando fenomeni come l'ideologia pop, la pop art, la religione pop, la scienza pop, ecc., coinvolgendo nel suo spazio tutto, da Che Guevara a Gesù Cristo. Le culture pop sono spesso percepite come un prodotto della cultura dei paesi economicamente sviluppati che sono in grado di dotarsi di una buona industria dell’informazione ed esportare i propri valori e stereotipi in altre culture. Quando si parla di Paesi in via di sviluppo, la cultura pop viene spesso considerata un fenomeno alieno, sicuramente di origine occidentale, con conseguenze molto distruttive. Nel frattempo, il “terzo mondo” possiede da tempo una propria cultura pop, che afferma, anche se in forma un po’ semplificata, l’identità culturale dei popoli non europei. Questa è l'industria cinematografica indiana e i film di kung fu, canzoni latinoamericane nello stile di "nueva trova", varie scuole arte popolare e musica pop. Negli anni '70 in Africa sorse la passione per la musica reggae e allo stesso tempo nacque il associato "movimento Rastafari" o "cultura Rastafari". Nello stesso ambiente africano, la passione per i prodotti della cultura pop a volte blocca il radicamento e la diffusione delle norme della cultura d’élite. Di norma, i suoi frutti sono più conosciuti nei paesi europei che in quelli in cui sono stati prodotti. Ad esempio, la produzione di maschere colorate originali in Africa si concentra principalmente sulla vendita ai turisti, e alcuni acquirenti hanno più familiarità con il significato culturale di queste maschere esotiche rispetto a coloro che traggono profitto dalla loro vendita.
Le difficoltà nel distinguere il confine tra cultura d'élite e cultura di massa a volte portano allo sviluppo di un movimento settario, quando una persona afferma ideali dubbi come valori che formano significato nella vita della società. Ciò è chiaramente illustrato dall’esempio del “movimento Rastafari”. È difficile determinare di cosa si tratti: una setta messianica, o un movimento religioso popolare, o un culto, o un movimento per l’identità culturale, o un surrogato dell’ideologia panafricana, o un movimento politico antirazzista, o la Negritudine” per i poveri”, forse una sottocultura dei bassifondi o una moda giovanile? Negli ultimi 60 anni, il Rastafari (Rastafarianesimo, più spesso semplicemente “Rasta”) ha attraversato metamorfosi sorprendenti, persino incredibili.
Il rastafarismo nacque come setta che divinizzò il Ras (sovrano locale) Tafari Makonnen (da cui il nome della setta), che fu incoronato il 2 novembre 1930 con il nome di Haile Selassie (“il potere della Trinità”). La setta è nata in Giamaica all'inizio degli anni '30, ma negli anni '60 i suoi aderenti sono comparsi tra i giovani di colore negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna. Negli anni '70 si trasformò in una religione pop, e poi semplicemente in una moda giovanile, provocando così un boom tra i giovani urbani del continente africano. Nonostante il fatto che "Rasta" sia arrivato in Africa dall'esterno, si è rivelato tanto atteso, riempiendo un certo vuoto spirituale.
Il primo studioso a condurre ricerche sul campo sulle sette rastafariane è stato il sociologo della religione George Eaton Simpson, autore di numerosi lavori sui culti di origine africana nei Caraibi. Basato sui materiali delle sue osservazioni nel 1953-1954. ha cercato di descrivere il culto dal punto di vista del funzionalismo in sociologia. Simpson considera la setta uno strumento per alleviare la frustrazione e adattare indirettamente la minoranza alla cultura dominante, attraverso la rinuncia a benefici inaccessibili alle classi sociali inferiori. La descrizione del culto stesso è data di sfuggita, generalmente ridotta a cinque punti principali: Haile Selassie è un dio vivente; Haile Selassie è onnipotente, anche l'energia nucleare gli è soggetta; i neri sono etiopi, una nuova incarnazione degli antichi ebrei; gli dei dei romani erano idoli di legno, gli inglesi considerano Dio uno spirito, incorporeo e invisibile, ma in realtà Dio è vivo e nel mondo - questo è Haile Selassie; il paradiso e il paradiso sono una menzogna, il paradiso dell'uomo nero è sulla Terra, in Etiopia. Notando la “retorica militante anti-bianca” del culto, Simpson lo considera del tutto pacifico e la belligeranza verbale è progettata per alleviare la tensione socio-psicologica. In generale, Simpson definisce Rastafari una controcultura, che però si trasforma in una sottocultura.
L'essenza delle idee Rastafari è la seguente: Haile Selassie I, Leone di Giuda, Re dei Re, ecc. - un discendente della casa di Salomone, la prossima incarnazione di Dio, il liberatore della razza prescelta - gli ebrei neri. Questo è il modo in cui i Rastafariani interpretano la storia ebrei, esposta nell'Antico Testamento: questa è la storia degli africani; Gli ebrei con la pelle chiara sono impostori e si atteggiano a popolo eletto di Dio. Per i loro peccati, gli ebrei neri furono puniti con la schiavitù a Babilonia. I pirati sotto Elisabetta I portarono i neri in America, cioè a Babilonia. Nel frattempo, Dio ha perdonato da tempo il suo popolo eletto; presto tornerà a Sion, che significa Addis Abeba. L'Etiopia è vista come il paradiso dell'uomo nero, l'America è l'inferno e la chiesa è uno strumento di Babilonia per ingannare i neri. La liberazione non li attende in paradiso, ma in Etiopia. La debolezza o la mancanza di cultura d’élite possono portare a tali movimenti settari.
Cultura media
Concetto cultura mediaè stato introdotto da N.A. Berdiaev. L'essenza di questa cultura è la ricerca della forma e del significato dell'esistenza umana tra atteggiamenti di vita estremi oppositivi, ad esempio, Dio esiste E Non c'è Dio. Questo concetto di cultura di mezzo è essenzialmente un tentativo di trovare un posto per una persona tra credenze estreme. È normale che un individuo scelga sempre uno di questi estremi e la scelta stessa è inevitabile per una persona. Il pensatore spagnolo José Ortega y Gasset scrive nella sua opera “La rivolta delle masse”: “Vivere significa essere condannato per sempre alla libertà, decidere per sempre cosa diventerai in questo mondo. E decidere instancabilmente e senza tregua. Anche quando ci abbandoniamo al caso, prendiamo una decisione – non decidere”. La scelta principale che una persona fa è quando decide sulla sua essenza, chi sarà. Una comprensione attiva di questa peculiarità delle persone divenne una caratteristica importante della cultura del Rinascimento, quando la società cercò di costruire il mondo non secondo le leggi divine, ma anche non secondo quelle demoniache, ma esclusivamente sulla base di quelle umane. Nell’Europa del XV secolo questa idea fu espressa da Mirandola nel trattato “Discorso sulla dignità dell’uomo”. Scrive il Pensatore: “Noi non ti diamo, o Adamo, né il posto, né una certa immagine, né un compito speciale, affinché tu abbia un posto, una persona e un dovere secondo a volontà, secondo la tua volontà e la tua decisione. L'immagine delle altre creazioni è determinata entro i limiti delle leggi che abbiamo stabilito. Non sei vincolato da alcun limite, determinerai la tua immagine secondo la tua decisione, in potere della quale ti lascerò”. L'ultima parte di questa citazione sottolinea non solo la possibilità scelta libera persona, ma anche che l'immagine che ne trarrà diventerà decisiva per la sua essenza, il suo pensiero. In altre parole, sarà l’individuo stesso a scegliere ciò che avrà potere su di lui. Se una persona si stabilisce in una forma spirituale ragionevole, seguirà requisiti ragionevoli, ma l’accettazione di una qualità demoniaca renderà l’individuo dipendente dal principio oscuro. Nel frattempo, la scelta è inevitabile, perché una persona, avendo due nature: potenza (potenzia) e attività (atto), non può fare a meno di sforzarsi di assumere una qualche forma. In Russia, il dilemma dei concetti opposti, di regola, veniva designato dal concetto divine E demoniaco e si è riflesso più volte nelle opere di molti filosofi russi. Quindi, F.M. Dostoevskij nel suo romanzo “I fratelli Karamazov” scrive: “Un uomo che è addirittura superiore nel cuore e ha una mente elevata, inizia con l'ideale della Madonna e finisce con l'ideale di Sodoma. È ancora più terribile per coloro che, avendo nell’animo l’ideale di Sodoma, non rinnegano l’ideale della Madonna…” Questo tipo di atteggiamento è in gran parte spiegato dal dogma della dottrina ortodossa, secondo il quale l'uomo è chiamato a diventare come Dio attraverso l'acquisizione dello Spirito Santo. Tuttavia, se ammettiamo la divinizzazione, allora è possibile anche il paragone con un demone.
Seguendo il pensiero filosofico russo e la cultura russa nel suo insieme, è opportuno notare che una cultura media è impossibile per una società umana che ha raggiunto lo stato. Come notato da A.P. Cechov, “...tra “c'è un Dio” e “non c'è Dio” c'è un campo enorme, che un vero saggio attraversa con grande difficoltà. Un russo conosce uno di questi estremi, ma la via di mezzo non gli interessa e di solito non significa nulla o molto poco”.