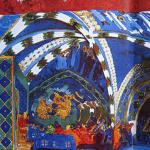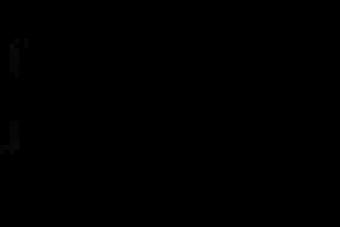Analisi del romanzo di A. Camus - "La Peste"
3. Immagine simbolica peste nel romanzo
romanzo filosofico peste camus
Contemporaneamente all'inizio dei lavori sulla seconda versione dell'opera (gennaio 1943), ebbe luogo un profondo ripensamento dell'immagine stessa della peste. Se all'inizio aveva i tratti vaghi di un disastro inspiegabile, combinato nella mente dello scrittore con la guerra che ne seguì, ora il romanziere cerca di presentarvi il Male, cioè una certa necessità dell'ordine mondiale esistente. Allo stesso tempo, l'orientamento anticristiano dei suoi pensieri ne predeterminava tutta la gravità problema eterno teodicea - come conciliare l'esistenza del Male con la bontà, la saggezza, l'onnipotenza e la giustizia di Dio - che si trova al centro del conflitto ideologico del romanzo.
Il temporale degli antichi e città medievali, la peste sembra essere stata debellata nel XX secolo. Nel frattempo la cronaca lo ha datato in modo abbastanza accurato: 194.... La data è immediatamente allarmante: allora sulla bocca di tutti c’era la parola “peste”: “peste bruna”. Un po’ più avanti, l’osservazione casuale che la peste, come la guerra, coglieva sempre di sorpresa, rafforza l’ipotesi incerta. La peste è una metafora già fissata nell'uso quotidiano. Perché, però, Camus ha dovuto ricorrere ad accenni ad una parabola allegorica invece che storica? Mentre lavorava a “La Peste”, scrisse nel suo diario: “Con l'aiuto della peste, voglio trasmettere l'atmosfera di soffocamento di cui soffrivamo, l'atmosfera di pericolo e di esilio in cui vivevamo allora. Allo stesso tempo, voglio estendere questa interpretazione all’esistenza in generale”. La catastrofe che scosse la Francia, agli occhi di Camus, fu un catalizzatore che la fece ribollire e traboccare. male del mondo, che vaga nella storia da secoli, e in generale vita umana.
La parola "peste" acquisisce numerosi significati e risulta essere estremamente capiente. La peste non è solo una malattia, un elemento malvagio, un flagello, e non è solo una guerra. Questa è anche la crudeltà delle sentenze giudiziarie, l'esecuzione dei vinti, il fanatismo della chiesa e il fanatismo delle sette politiche, la morte di un bambino innocente, una società strutturata estremamente male, così come i tentativi con le armi in mano di ricostruire di nuovo. È familiare, naturale, come respirare, - dopo tutto, "oggigiorno siamo tutti a poco a poco tormentati". Per ora il male-peste dorme in silenzio, a volte dà esplosioni, ma non scompare mai del tutto.
La cronaca di diversi mesi dell'epidemia di Orano, quando metà della popolazione, “gettata nella bocca di un inceneritore, volò in aria con un fumo grasso e appiccicoso, mentre l'altra, incatenata nelle catene dell'impotenza e della paura, aspettava il suo svolta”, implica il dominio dei nazisti in Francia. Ma l'incontro stesso dei compatrioti di Camus con gli invasori, come l'incontro degli Orani con un mostro della peste disperso nei microbi, secondo la logica del libro, è un difficile incontro dell'umanità con il suo Destino.
Nel ripensare l'immagine della peste, trasformatasi in una cupa metafora del Male mondiale, è stato giocato un ruolo degno di nota, e proprio all'inizio dei lavori su nuova edizione romanzo, ha interpretato motivi biblici. Prima voce in " I Quaderni“Camus, direttamente correlato alla seconda versione di “La Peste”, consisteva in una serie di brani tratti dalla Bibbia – quei luoghi in cui si parla di Dio che manda una pestilenza sulle persone che Gli disobbediscono. Ecco uno di questi passaggi, che descrive espressamente l'ira e l'ira di Dio rivolte a chiunque osi trasgredire la Sua alleanza: “E io porterò su di te una spada vendicativa in vendetta per l'alleanza; Ma se vi nascondete nelle vostre città, manderò contro di voi la piaga e sarete consegnati nelle mani del nemico». La peste, quindi, appare nella coscienza di Camus non solo, e nemmeno tanto, come opera di un miserabile Caligola bruno, ossessionato dall'idea del dominio autocratico, ma come un principio ineludibile dell'essere, un principio incrollabile di ogni cosa. l'esistenza, quel Male, senza il quale non esiste il Bene. Ma chi è responsabile del Bene e del Male? Nel 1946, parlando ai monaci del monastero domenicano di La Tour-Mabourg, Camus disse: “Tutti siamo di fronte al male. Quanto a me, a dire il vero, mi sento come Agostino prima dell’adozione del cristianesimo, che diceva: “Cercavo da dove viene il male e non riuscivo a trovare una via d’uscita da questa ricerca”. La soluzione di Agostino è nota: il bene viene da Dio, l’uomo, allontanatosi da Dio nella Caduta, sceglie il male con la sua volontà. “Nessuno è buono”, conclude Agostino. Camus trasferisce il problema del male su un piano diverso, il piano della posizione di vita reale di una persona che si trova quotidianamente ad affrontare il vero male. Se Dio, con tutta la sua bontà, permette il male come mezzo per illuminare e punire una persona colpevole, come dovrebbe comportarsi una persona? Dovrebbe sottomettersi docilmente, dovrebbe inginocchiarsi con umile sottomissione quando il male minaccia la sua esistenza, l'esistenza dei suoi cari?
In “La Peste” la posizione di rassegnazione al Male, che, secondo Camus, è caratteristica della visione cristiana del mondo, è rappresentata nell'immagine di padre Paplu. Il dotto gesuita, divenuto famoso per i suoi scritti su Agostino (dettaglio importante!), pronuncia un'ardente predica alla fine del primo mese di peste. La sua tesi principale può essere espressa in poche parole: “Fratelli miei, ci sono capitati dei guai e ve li meritate, fratelli”. Citando un versetto dell'Esodo sulla peste, una delle dieci terribili “piaghe d'Egitto”, il predicatore aggiunge: “Quando questo flagello apparve per la prima volta nella storia per sconfiggere i nemici di Dio, il Faraone resistette ai disegni dell'Eterno, e la peste lo costrinse a inginocchiarsi. Fin dall'inizio della storia umana, il flagello di Dio ha umiliato i duri di collo e i ciechi. Pensaci attentamente e inginocchiati”. La peste nel sermone di Paneloux viene interpretata come la “lancia cremisi” del Signore, che punta inesorabilmente alla salvezza: lo stesso flagello che colpisce crudelmente le persone e le spinge nel Regno dei Cieli. Nella peste, sostiene Paneloux, vengono dati “l’aiuto divino e la speranza eterna del cristiano”. Bisogna amarlo veramente e “Dio farà il resto”.
Questa, secondo Camus, è la posizione della visione del mondo del cristianesimo, che è predeterminata posizione di vita una persona che guarda a Dio con speranza. Come è stato più volte sottolineato, Camus ritrae l'immagine del cristianesimo nei suoi pensieri e nei suoi scritti con eccessiva crudeltà. Ma dietro la sua categoricità, che nasconde il sincero desiderio del pensatore di comprendere l'inspiegabile con la mente, si può discernere non un distruttivo desiderio di negazione, ma un'inesorabile sete di comprensione, un efficace bisogno di dialogo spirituale. La disputa di Camus con il cristianesimo non è stata condotta nel linguaggio dell'”esposizione”, ma nel linguaggio del dialogo.
Anche la visione del mondo del cristianesimo presentata nella prima predica di padre Paneloux ha incontrato valutazioni contrastanti. Così J. Herme, autore di un'interessante monografia sui collegamenti tra il pensiero di Camus e il cristianesimo, nota a proposito di questo sermone che "solo con grandi riserve un cristiano accetterà di riconoscere" in esso la vera "parola del Vangelo". Tuttavia, in uno studio teologico speciale dedicato al problema del male nei tempi moderni, incontriamo un’opinione completamente opposta: “Questa predica, per quanto controversa possa sembrare, è molto plausibile nella bocca di un prete degli anni ’30, quando è stato pronunciato." In effetti, storia vera L’Europa della fine degli anni ’30 e dell’inizio degli anni ’40 avrebbe potuto benissimo fornire a Camus esempi di rassegnazione cristiana all’assalto incontrollabile del male. Secondo R. Quillot, Camus gli disse che, mentre lavorava al capitolo sul sermone di Paneloux, aveva in mente “alcuni messaggi di vescovi e cardinali del 1940, che invitavano nello spirito del regime di Vichy al pentimento generale”. La storia, come vediamo, nella mente di Camus era strettamente intrecciata con Dio: due Assoluti incrollabili minacciavano l’uomo e la vita. Uno con la vera distruzione, l'altro con una richiesta di sottomissione. Dio e la Storia si rivelarono due inesauribili nei suoi pensieri, fondendosi ogni tanto in uno solo flusso distruttivo, fonti del Male: “C'è la morte di un bambino, che significa la tirannia divina, e c'è la morte di un bambino, che significa la tirannia umana. Siamo intrappolati tra loro." L'uomo può o rassegnarsi all'arbitrarietà, ritrovandosi così coinvolta nel Male, oppure negare l'arbitrarietà, sia divina che storica, resistendovi attivamente e affermando così la propria innocenza. Camus giustifica ancora una volta l'uomo: il male non è nell'uomo, e l'uomo è obbligato e chiamato a combattere il male. L'uomo, in virtù della sua umanità, è destinato alla rivolta.
Avendo saldamente collegato l'immagine della peste con l'immagine del male, il romanziere, nel periodo 1943-1944, chiarì attentamente i poli del principale conflitto ideologico dell'opera. "Uno di argomenti possibili“”, scrive nel gennaio 1943, “la lotta tra medicina e religione...” A fine anno, lo scrittore acuisce ulteriormente la contrapposizione tra ribellione e umiltà: “Medicina e religione: sono due mestieri, e sembrano potersi conciliare tra loro. Ma ora che tutto è estremamente chiaro, diventa evidente che sono inconciliabili”. Poco dopo, delineando i tratti dell'immagine del dottor Rieux, pensata per esprimere una visione del mondo opposta a quella religiosa, il romanziere formula chiaramente significato profondo di questa opposizione: «Il medico è nemico di Dio: lotta con la morte... il suo mestiere è essere nemico di Dio».
"Simplicissimus" di G. Grimmelshausen come romanzo di formazione
Il personaggio principale del romanzo è Simplicius Simplicissimus, soprannominato così per la sua estrema semplicità. Vive nella casa del “padre” come un fiore selvatico: a nessuno importa della sua educazione. Simplicissimus è molto ignorante...
“Tragedia personale” nelle piccole tragedie di A.S. Puškin
Non ha retroscena questa commedia di Pushkin. Sembra che per un capriccio del destino, del tutto per caso, Pushkin abbia portato con sé a Boldino un volume di opere teatrali inglesi, una delle quali - la poesia di Wilson - ha individuato, strappato una scena...
COME. Pushkin come scrittore di prosa, drammaturgo, storico
Generazioni e generazioni di lettori e ricercatori si godono questi capolavori in miniatura e cercano di padroneggiare e comprendere l'immensità del loro contenuto: su di essi sono stati scritti centinaia di articoli, studi, monografie...
Immagini di donne nei romanzi di Dreiser
"Jenny Gerhardt" (1911) è un romanzo che ha segnato l'approfondimento del realismo di Dreiser. Rispetto a Sorella Carrie, la prospettiva dell'immagine in questo romanzo cambia notevolmente. Le idee deterministiche di Dreiser si stanno manifestando ancora più attivamente di prima...
Ritratto femminile nel romanzo di L.N. "Guerra e pace" di Tolstoj (usando l'esempio dell'immagine di Elena)
L'immagine di Helen, una rappresentante della famiglia Kuragin, riflette chiaramente attitudine negativa Tolstoj agli ambienti laici della nobiltà pietroburghese, dove regnavano doppiezza e menzogna, mancanza di principi e meschinità...
Il motivo della bufera di neve nella poesia di B.L. Pasternak
Il motivo della bufera di neve riceve una varietà di interpretazioni: una bufera di neve è un elemento di rivoluzione, un elemento ispirazione creativa, elementi di freddo, oscurità, neve. L'elemento è una forza distruttiva. E non puoi parlare degli elementi del male e degli elementi del bene, perché...
Immagine " piccolo uomo"nel romanzo di F. Sologub" Piccolo diavolo"
Obiettivo: rivelare l'immagine dell'autore come uno di caratteri in un romanzo, per mostrare l'atteggiamento dell'autore nei confronti dei suoi personaggi e della sua epoca. Obiettivi: 1. studiare la letteratura su questo argomento; 2. raccogliere materiale che riveli il punto di vista dell'autore sull'epoca descritta...
Onegin è il mio buon amico. 2.1. Divagazioni liriche sulla creatività, sull'amore nella vita del poeta. Vedi capitolo 1, strofa 55-59. La creatività, come l'amore, gioca un ruolo molto importante nella vita di un poeta. Lui stesso ammette che: Fammi notare comunque...
L'immagine del teatro-mondo nel romanzo "Don Chisciotte" di Cervantes
Cervantes aveva un grande talento creativo ed era ricco di un'ampia varietà di eventi e impressioni vita privata gli ha insegnato una profonda comprensione della realtà. Ispirato migliori aspirazioni della sua epoca...
Immagine nuove generazioni nel romanzo di E. Burgess " Un'Arancia Meccanica"
"La giovinezza non è eterna, oh sì. E poi, nella tua giovinezza sei proprio come un animale, o qualcosa del genere. No, nemmeno un animale, ma piuttosto una specie di giocattolo che viene venduto ad ogni angolo - un po' come un omino di latta con una molla dentro...
L'immagine di un emigrante nella prosa di G. Gazdanov
Un evento davvero cruciale e straordinario avviene in vita letteraria Gaito Gazdanov abbastanza presto, all'inizio del 1930. Nell’estate del 1929 completò il lavoro sul suo primo romanzo, “An Evening at Claire’s” (il testo dell’editore è datato “Paris...
La natura dell'unità del ciclo in prosa di Gogol "Mirgorod"
Compilazione di Mirgorod Formazione del ciclo di Gogol Notato a lungo caratteristica distintiva La creatività di Gogol: quando descrive la realtà, conferisce deliberatamente alla raffigurata un attributo territoriale e, definendo il luogo dell'azione a Dikanka, Sorochitsa...
Analisi comparativa Il romanzo di Jerome David Salinger Il giovane cacciatore di segale
Il personaggio principale del romanzo è Holden Caulfield. Questo è un giovane che cerca di trovare il suo posto nella vita. Più di ogni altra cosa, Holden aveva paura di diventare come tutti gli adulti. Era già stato espulso da tre college per scarsi risultati accademici. Holden odia il pensiero...
Il tema del crimine nelle opere di F.M. Dostoevskij e P. Suskind: verso la ricerca della parentela letteraria
introduzione
Sin dai tempi antichi, la cultura francese è stata generosa con i "moralisti" - scrittori di un tipo speciale che hanno lavorato con successo ai confini della filosofia e della letteratura in quanto tali. In realtà moralista francese, a giudicare dizionari esplicativi, solo uno dei suoi significati, e non il primo, coincide con il "moralista" russo - un insegnante morale edificante, un predicatore di virtù. Innanzitutto, questa parola implica proprio la combinazione in una persona di un maestro della penna e di un pensatore, che discute nei suoi libri i misteri della natura umana con arguta franchezza, come Montaigne nel XVI, Pascal e La Rochefoucauld nel XVII, Voltaire, Diderot, Rousseau nel XVIII secolo.
La Francia del XX secolo propone un'altra costellazione di tali moralisti: Saint-Exupéry, Malraux, Sartre... Tra i primi di questi grandi nomi va giustamente menzionato Albert Camus. Quando morì in un incidente stradale nell'inverno del 1960, Sartre, con il quale furono dapprima vicini e poi nettamente divergenti, in una nota di addio su Camus delineò il suo aspetto e il suo posto nella vita spirituale in Occidente: “Camus rappresentava nel nostro secolo - e in una disputa contro storia attuale- l'erede odierno dell'antica stirpe di quei moralisti la cui opera rappresenta probabilmente la linea più originale Letteratura francese. Il suo ostinato umanesimo, ristretto e puro, severo e sensuale, intraprese una battaglia dall'esito incerto contro le tendenze schiaccianti e brutte dell'epoca. Eppure, con l’ostinazione del suo “no”, lui – a dispetto dei machiavellici, a dispetto del vitello d’oro degli affari – ha rafforzato le basi morali nel suo cuore”. Per ragioni di precisione, vale solo la pena ricordare che ciò che ha detto Sartre si applica quindi giustamente a Camus anni maturi. Camus, come non è sempre stato, ma come è diventato, alla fine, veniva da molto, molto lontano, da punti di partenza completamente diversi.
La storia della creazione del romanzo “La Peste”
“Dal punto di vista del nuovo classicismo”, scrive Camus poco prima di terminare il lavoro su un romanzo sulla peste, come se cercasse di consolidare i concetti estetici e filosofici dell’opera, “La Peste può forse essere considerata la prima esperienza in raffigurante la passione collettiva”. Il lavoro su quest'opera, iniziato nel 1938, ma proceduto in modo particolarmente intenso subito dopo il completamento de "Il mito di Sisifo" (febbraio 1941), fu completato a cavallo tra il 1946 e il 1947, e il romanziere, sperimentando acutamente le difficoltà di creare un romanzo, quasi non si rifiutava di pubblicarlo. Nell'autunno del 1946, nei Quaderni apparve una voce caratteristica, che rifletteva i profondi dubbi dello scrittore e la sua vaga premonizione di successo creativo: "" Peste ". Mai nella mia vita ho provato un tale sentimento di fallimento. Non sono nemmeno sicuro che arriverò alla fine. Eppure a volte...”
Il lavoro su The Plague è progredito in modo estremamente difficile e lento. L'opera ha assorbito i frutti di gravi cambiamenti nella posizione ideologica dello scrittore, predeterminati da eventi tragici Storia europea 1939-1945, riflette l'intensa ricerca estetica del romanziere, strettamente connessa, come abbiamo visto nella sezione precedente, con la logica interna del suo sviluppo pensiero filosofico. Storia creativa"La peste", un romanzo che è stato universalmente percepito come una cronaca della "resistenza europea al nazismo" e, aggiungiamo, a qualsiasi totalitarismo, è una sorta di cronaca dell'evoluzione spirituale del suo autore.
Le prime note sul romanzo risalgono al 1938, quando, dopo il fallimento di " Buona morte“Lo scrittore è completamente immerso nello sviluppo di nuove idee. I Quaderni contengono un ampio schizzo in prosa sul difficile amore di due giovani e poveri. In un mondo di povertà e di lavoro estenuante, in un mondo di privazioni e sofferenze, dove “non c’è posto per l’amore”, l’amore, nonostante tutta l’assurdità dell’esistenza, è in grado di unire saldamente due persone nel “deserto incantato” della vita. felicità, “che una persona sperimenta quando vede che la vita giustifica le sue aspettative”. In "The Plague", questo frammento sarà incluso quasi immutato nella toccante confessione di Joseph Grand, un modesto funzionario dell'ufficio del sindaco, che adempie coraggiosamente al suo dovere nella lotta comune contro la distruttiva epidemia, e nelle sue brevi ore libere alle prese con la prima frase del romanzo, che dovrebbe giustificarlo agli occhi di Jeanne, che ha lasciato il marito perché “non è riuscito a sostenerla nella convinzione che fosse amata”. L'amore, così, diventa inizialmente gli antipodi della peste, il suo forza effettiva rafforza la volontà di una persona di resistere al male.
Il settembre 1939 precipita l’Europa in un freddo crepuscolo terribile guerra, che ha colto molti di sorpresa, come se si fosse trattato di un vero e proprio disastro naturale. Camus vuole offrirsi volontario, ma la commissione medica militare lo dichiara inabile al servizio. Una risposta un po' romanzata a questo esame appare nei Quaderni: «Ma questo bambino è molto malato», disse il tenente. “Non possiamo portarlo…” Una serie di riflessioni diaristiche di Camus risalenti all'allarmante autunno del 1939 dimostrano che l'assurdità esistenza umana, che fino ad ora aveva avuto nella mente dello scrittore una dimensione prevalentemente metafisica, cominciò ad acquisire contorni sociali distinti. La guerra incarnava visibilmente l’assurdità della storia: “Scoppiò la guerra. Dov'è la guerra? Dove cercare, oltre alle notizie a cui credere e ai manifesti da leggere, le manifestazioni di questo evento assurdo?... La gente si sforza di crederci. Stanno cercando il suo volto, ma lei si nasconde da noi. La vita regna tutt’intorno con i suoi magnifici volti.” Già il 7 settembre, la sensazione dell'improvvisa catastrofe imminente è stata completata dai primi timidi tentativi di trovare i veri motivi dell'assurdità della storia, e anche allora fattori sociali lo scoppio di una catastrofe non può essere concepito dal giovane scrittore separatamente dalla responsabilità personale: “Tutte le persone volevano capire dov'era la guerra - e cosa c'era di vile in essa. E così si accorgono che sanno dov'è lei, che lei è in loro, che è in questo imbarazzo, in questo bisogno di scegliere, che li costringe ad andare al fronte e allo stesso tempo tormentarsi di non avere il coraggio di restare a casa, o di restare a casa e allo stesso tempo tormentati dal fatto di non andare a morte insieme ad altri. Eccola, è qui e la stavamo cercando cielo blu e nell'indifferenza del mondo circostante. È nella terribile solitudine di chi combatte e di chi resta nelle retrovie, nella vergognosa disperazione che travolge tutti e nel declino morale che appare sui loro volti nel tempo. Il regno delle bestie è arrivato." La consapevolezza della responsabilità personale in queste riflessioni di Camus è accompagnata dall'esperienza di determinare la vocazione di una persona e di un artista negli anni difficili del regno del male: “Il desiderio di isolarsi - dalla stupidità o dalla crudeltà verso il suo africano “ origine” - Orano diventa per Camus l'immagine di una città europea.
Cos'è l'onestà? - ...chiese Rambert,
Essere onesti significa fare il proprio lavoro.
A. Camus “La Peste”
Albert Camus - Scrittore francese, laureato premio Nobel, filosofo, partecipante al movimento di Resistenza, in generale, una persona straordinaria. Camus come me scrittore interessante. L’opera stessa “The Plague” mi ha colpito non tanto come testo, ma piuttosto come sottotesto. Quando leggi un romanzo, devi capire più di ciò che è scritto, oppure chiedere spiegazioni all'insegnante, oppure leggere prima il libro di testo o la prefazione del romanzo - e quindi sarà più facile e comprensibile da leggere. Questo è un po’ sorprendente. Dopotutto, con L. Tolstoj o F. Dostoevskij, O. Balzac o C. Dickens, comunichi semplicemente con l'autore, con i suoi eroi, diventi persino partecipe degli eventi (così sembra, almeno). Per leggere il romanzo “La Peste”, bisogna essere preparati. Bisogna essere un po’ filosofo, un po’ analista, un po’ storico… Tutto inizia con la prima frase: “ Eventi interessanti, che è tratto dalla trama di questa cronaca, ebbe luogo 194... anni ad Orano”. Perché l'autore non ha indicato l'ultima cifra? Qual è il punto di tutto questo? Intrigo per il lettore in modo che lui stesso possa indovinare di che tipo di "piaga" parleremo?
Caos... puro caos... Dicono che non esistono incidenti. Non è un caso che mi sia caduta addosso la parola “caos”. Questo è un suggerimento! In effetti, se ti avvicini al tema dell'opera fin dall'inizio, dalla fonte, lì puoi trovare la parola “caos”. È alla base della visione del mondo dello scrittore e questa percezione del mondo si è successivamente riflessa nelle sue opere. E le sue opinioni, come le opere di Camus, portano l'impronta dell'esistenzialismo. Cosa hanno dimostrato gli esistenzialisti? Sono convinti che il mondo sia caos e che non vi sia alcuno schema. Tutto accade per caso. Un uomo è solo, non riesce a capire il significato della sua vita. L'unica cosa che le dà l'opportunità di comprendere il significato della propria esistenza è una sorta di situazione critica. Ad esempio, una persona si trova in una situazione limitante (è sull'orlo di qualcosa, a volte sull'orlo della vita o della morte), e poi fa la sua scelta morale, dimostrando a se stessa che non è posto vuoto in questo mondo, qualcosa dipende ancora da lei. Quindi, davanti a noi c'è il romanzo "La peste". Situazione estrema: una terribile malattia, la peste, arriva nella città di Orano (in figuratamente l'autore intende anche fascismo: guarda la data! - e qualsiasi disastro in generale). Un normale medico, Bernard Rie, nota il pericolo: i ratti possono diffondere l'infezione e le persone inizieranno ad ammalarsi. Se le misure venissero adottate prima, il pericolo per le persone sarebbe minore. Ma coloro da cui dipende il processo decisionale aspettano qualcosa. Forse per non creare panico, o forse per non distrarsi dalle faccende di oggi - dopotutto il problema non è ancora caldo, forse tutto passerà... Cosa fare? Nessuno obbliga il dottor Rie a fare nulla: magari non dà l'allarme, non crea squadre sanitarie... Ma lo fa. Non può fare diversamente. In una situazione così limite, inizia a pensare più non a se stesso, ma alle persone, all'intera città. E anche il giornalista Rambert si rivela una persona umana. È finito accidentalmente in quarantena, vuole scappare da questa città nella sua nativa Parigi. E all'inizio cerca con tutte le sue forze di scappare dall'organo infestato dalla peste. Semplicemente non funziona. Rambert cerca una via d'uscita. Ed ecco qua. Può scappare in un'auto che lo porterà fuori dall'Organo inosservato. Ma no! Rambert ora si sente responsabile della sorte delle persone sfortunate. In una situazione in cui deve decidere quale vita è più importante per lui, rifiuta la salvezza egoistica. Rimane ad Orano e lavora per il bene della gente.
Mi sembra che proprio come Camus ha seguito il percorso della graduale conoscenza del mondo, così i suoi personaggi cambiano nel corso del romanzo. Quindi, mondo insensato, è impossibile sconfiggere la peste (perché così come è arrivata in città, se n'è andata allo stesso modo, e non è stato il vaccino ad aiutare, ma chissà cosa), ma una persona deve combattere. Ciò è necessario almeno per ridurre la sofferenza delle persone e mostrare reciproca misericordia umana. E se ogni persona fa onestamente il proprio lavoro, allora il mondo potrà diventare un posto migliore e, forse, questo mondo non sarà “ostile e incomprensibile”. Albert Camus, attraverso la metafora e l'allegoria, ha mostrato nel romanzo il male che è sempre esistito tra le persone. La vita dell'umanità è sempre stata accompagnata da guerre, omicidi, disonestà, ipocrisia e meschinità sono sempre esistite. Sfortunatamente, questo non è scomparso. In effetti, il “bacillo della peste” può rimanere dormiente da qualche parte in una pila di biancheria per anni, e poi scoppiare e causare problemi. Il fascismo scoppiò e “afflisse” i popoli e gli stati circostanti. C'è stata una guerra, ci sono stati molti morti. Ma la gente ha resistito a questo male. E alla fine hanno vinto il male e si sono sentiti esseri umani. Non da persone infette dalla peste, “ma da persone dal corpo sano e pulito” (citazione da W. Whitman). La gioia della vittoria sul male, sulla malattia, sull'impotenza è la gioia della vera vittoria! Vale la pena vivere per questo!
Nel romanzo “La Peste” (1947) pessimismo Albert Camus in relazione al mondo assurdo si combina con l'ottimismo morale. Il concetto di uomo in quest'opera di Camus è pieno di stoicismo: lo scopo dell'uomo è soffrire, lottare e resistere. Il romanzo è stato creato nel 1941-1943 ed è stato pubblicato nel 1947 (inizio del testo: "Gli eventi interessanti presi in considerazione nella trama di questa cronaca hanno avuto luogo nel 194 ... a Orano"). Nel cronotopo dell'opera è molto più importante indicare il tempo storico: gli anni Quaranta del XX secolo - il tempo della più grande tragedia dell'epoca - il tempo della Seconda Guerra Mondiale. Secondo lo stesso Camus, il “contenuto esplicito” di “La Peste” è la lotta della Resistenza europea contro il nazismo”.
“Con l'aiuto della peste voglio trasmettere l'atmosfera di soffocamento in cui abbiamo faticato, l'atmosfera di minaccia e di esilio in cui abbiamo vissuto. Ho però esteso il significato di questa immagine all’essere in generale”. La peste è un'altra manifestazione dell'assurdità del mondo, simbolo della vita. Pertanto, la cosa principale nel romanzo è l'interpretazione dei problemi filosofici senza tempo dell'esistenza, a cui è collegato il suo secondo, profondo piano.
Il significato filosofico è stato realizzato sotto forma di un romanzo di parabole.
La trama del romanzo è una cronaca dell'anno della peste ad Orano. L'autore di questa cronaca è il dottor Bernard Rieux, che, in virtù della sua professione, si trova al centro degli eventi. Il medico vuole lasciare un ricordo delle ingiustizie e delle violenze commesse contro gli appestati. Egli proclama: “Le persone meritano ammirazione piuttosto che disprezzo”.
Il narratore si sforza di ricreare il più fedelmente possibile ciò che ha visto e sentito, facendo riferimento a documenti, atti, testimonianze di Orans, cercando di aderire al tono di un testimone imparziale. La cronaca ripercorre l'origine e lo sviluppo di questa epidemia a seconda delle stagioni e della diffusione della malattia. La morte attende tutti, nessuno escluso, e la cosa più importante per l'autore è il comportamento delle persone in una "situazione limite".
La peste attacca inaspettatamente, nessuno se lo aspettava. Quando i topi muoiono in massa in città, nessuno prende sul serio questi presagi di un'epidemia di peste. “Come potevano credere in una pestilenza che cancellava immediatamente il futuro?... Si consideravano liberi, ma nessuno sarà libero finché esisterà la sventura”.
Tre piani narrativi nella struttura di significato a più livelli di “The Plague” (secondo Yu. Kovbasenko):
1. una descrizione realistica della lotta degli Oraniani contro una terribile malattia (sebbene storicamente non ci fosse un'epidemia del genere ad Orano, qui l'autore entra nella sfera della generalizzazione senza tempo);
2. una rappresentazione allegorica del movimento di Resistenza contro la “peste bruna”, contro il fascismo e il nazismo (anche lo stesso Camus partecipò al Movimento di Resistenza);
3. “Illustrazione artistica” di importanti disposizioni della filosofia dell'esistenzialismo, prima di tutto, la necessità scelta morale una persona sulla propria strada in una “situazione limite”. Esattamente scelta libera, secondo Camus, crea personalità. “Esistere è scegliere te stesso.”
La diversità semantica rende quest'opera vicina a un mito, a una parabola, e allo stesso tempo è un romanzo di avvertimento, che lo rende un fenomeno universale e senza tempo.
Il critico letterario D. Nalivaiko caratterizza il romanzo di Camus “La peste” come segue: “Con natura del genere Quest'opera di Camus è un romanzo con parabole; appartiene a un genere diffuso nella prosa intellettuale moderna ed è caratterizzato da universalità e ambiguità di contenuto. Inoltre, “La Peste” è uno dei più grandi fenomeni di questo genere, insieme a “Il Processo” e “Il Castello” di Kafka, “La Fossa” di Platonov, “Il Signore delle Mosche” di Golding, ecc.”
Utilizzando la stilizzazione come genere di cronaca, Albert Camus sottolinea l'attenzione del lettore sull'oggettività di ciò che viene raffigurato, selezionando speciali mezzi linguistici– ogni parola è sorprendentemente accurata significato lessicale, anche se usato in senso figurato; la storia non ha quasi alcuna colorazione espressiva-emotiva, la presentazione degli eventi e i commenti sono molto sobri, anche un po' distaccati, come nei poemi epici. La storia della lotta contro la peste è scritta quasi in un protocollo. Camus, oltre al punto di vista del narratore principale, introduce anche una visione della peste e della sua influenza su Orano e sugli Oraniani e su altri personaggi dell'opera (il diario di Tarrou, i sermoni di padre Panelu, i dialoghi dei personaggi, una descrizione dei loro pensieri e aspirazioni), grazie al quale si forma un quadro sfaccettato e veritiero della tragedia.
Il dottor Rieux è stato uno dei primi a rendersi conto della criticità della situazione e a capire cosa stava succedendo a Orano. Numerose opinioni del narratore e dei suoi amici, sparse nel testo del romanzo, ci ricordano costantemente la “doppia visione delle cose”. Già nell’epigrafe Camus focalizzava l’attenzione sulla combinazione di una trama immaginaria sul blocco di Orano colpita dalla peste con la reale situazione storica dell’Europa, colpita dai bacilli della “peste bruna” (l’epidemia di Hitler veniva metaforicamente definita così, quindi il titolo stesso dell'opera fu percepito come un'allusione all'occupazione nazista).
Il tema della conclusione diventa uno dei principali dell'opera. Ad esempio, l'isolamento dei malati di peste negli ospedali e nei campi di quarantena è associato alle prigioni e ai campi di concentramento della Gestapo; la procedura per la sepoltura di massa dei morti è associata alle esecuzioni di massa e al rogo di persone nei crematori. Lo stesso Camus ha osservato: “La prova di ciò è che il nemico, non direttamente nominato nel romanzo, è stato identificato da tutti: in tutti i paesi d'Europa. "La Peste è più di una cronaca di resistenza." Con “qualcosa di più” Camus probabilmente intendeva intendere l’epidemia Orange come una sintesi simbolica di numerose catastrofi storia moderna- dai regimi totalitari dell'URSS, dell'Italia, della Spagna, dell'Ungheria fino alle moderne dittature politiche, conflitti interetnici, guerre locali, ecc. L'intera storia dell'umanità appare come una serie di "disastri collettivi" che hanno causato milioni di vite umane, il che è per questo lo scrittore scelse l'immagine della peste, della malattia, nera compagna dell'umanità.
Nel testo del romanzo, la peste diventa un simbolo del Male metafisico, una terribile forza distruttiva che minaccia la vita umana, e l'autore considera i problemi dell'opera dal punto di vista delle principali questioni esistenzialiste: la ricerca di sostegno spirituale in un mondo assurdo, l'esperienza di una persona di una "situazione borderline", la scelta morale e la responsabilità per essa e così via. Proiezioni "fattografiche" e "simboliche" sono costantemente sovrapposte l'una all'altra nel testo, grazie alle quali Oran e gli Orans si trasformano in un micromodello dell'umanità in eventi storici tragici dal punto di vista della filosofia, dell'etica e dell'estetica dell'esistenzialismo.
Rivolgendosi all'immagine della peste come catastrofe umana universale, Camus crea un ritratto collettivo degli Oraniani, dettagliandolo con tipi di immagini specifici, come Rieux, Cottard, Panelu, Rambert, Grand, Tarrou e altri.
È il dottor Rieux il più aperto a risolvere le questioni esistenziali. Si ritrova proprio nell'epicentro dell'epidemia, ma non solo il giuramento di Ippocrate lo obbliga a combattere altruisticamente la peste. Si sforza innanzitutto di proteggere la persona dentro di sé, uomo onesto chi sta semplicemente facendo il suo lavoro, il suo dovere.
Jean Tarrou è il più stretto collaboratore e amico del dottor Rieux. Una delle immagini più interessanti e controverse del romanzo. Coraggioso amante della vita, un uomo con sentimento interiore libertà e dignità umana, personalità straordinaria, “il migliore tra i migliori”, Tarrou è stato lacerato per tutta la vita dalla contraddizione tra moralità e politica. Figlio di un procuratore aggiunto, all'età di 17 anni si rese conto che sia i funzionari governativi che i combattenti per la liberazione dell'umanità (cioè i rivoluzionari) sono assassini inconsapevoli di persone, "persone vive".
Il suo motto di vita era la convinzione che bisogna sempre “schierarsi dalla parte delle vittime per limitare in qualche modo la portata del disastro”. Fu lui ad avviare la creazione di squadre sanitarie nell'Oran afflitta dalla peste. Nonostante l’elevata moralità dell’eroe, l’autore permette alla peste di uccidere Tarra, e motivo principale che, in primo luogo, la morte ha sempre la meglio (secondo il vecchio asmatico), e in secondo luogo, portava nel suo cuore un'estrema stanchezza per la lotta che dimorava dentro di lui.
“Confessando” al dottor Rieux, Tarrou ha detto che dall'età di 17 anni è stato “tormentato”, contagiato dalle contraddizioni del mondo, che cerca a tutti i costi di uccidere una persona e allo stesso tempo di giustificarsi. Camus si riferisce anche alla “piaga” come allo stato di un osservatore che può combattere, ma non lo fa; e lo stato della società che esige la condanna a morte; e ignoranza e menzogna, perché il male è la loro conseguenza. Anche vivere nell’illusione viene “afflitto” quando si semina la morte. Anche se contribuisci inconsapevolmente alla morte di qualcuno, secondo Camus, sei "afflitto".
Gli eroi del romanzo si trovano ad affrontare un problema: come vivere in un mondo assurdo dove regna il male; come realizzare il comandamento cristiano “Non uccidere!” se i bambini innocenti muoiono senza colpa: come “non essere nemico di nessuno”, “è possibile diventare santi senza Dio”, è possibile trarre profitto dal dolore e morte degli altri, come preservare una persona dentro di sé.
Gli eroi di Camus fanno le loro scelte in modo diverso. Il percorso del giornalista Raymond Rambert, parigino e “forestiero” a Orano, non è facile. Dapprima cerca di convincersi che gli affari degli Oraniani non lo riguardano, che il suo scopo principale è amare una donna, senza la quale non può immaginare la sua vita. Alla ricerca di modi per lasciare Oran tormentato dalla peste, Rambert arriva alla squadra sanitaria, ma, avendo l'opportunità di uscire di nascosto dalla città, Rambert rimane deliberatamente con i combattenti contro la peste. Il valore della sua felicità individuale impallidisce sullo sfondo della tragedia di Orano. Dopo aver superato la prova della peste, se ne rese conto sullo sfondo dolore comune non potrà più essere felice come prima.
La peste predeterminò anche i cambiamenti ideologici di padre Panelu. In primo luogo, spiega la peste come un “flagello di Dio”, come la punizione di Dio nei confronti delle persone per i loro peccati. Il suo primo sermone è pieno di rabbia cristiana inconciliabile, parla da un alto pulpito, sentendosi per un momento come se fosse al posto di Dio. Le sue parole spaventano le persone e seminano paura nelle loro anime. Padre Panelu vi invita ad accettare umilmente le difficoltà, senza affidarvi alla medicina o ai medici, ma ad avere piena fiducia nella volontà di Dio. Tuttavia, l'idea della punizione nella visione del mondo di padre Panelu cede quando lui, accettando centinaia di morti con fredda stabilità, essendo uno dei membri più attivi della squadra sanitaria, assiste alla morte di un ragazzo innocente, il figlio dell'investigatore Ottone.
Padre Panlu chiede a Dio di salvare questo bambino, ma il bambino muore. E poi il padre dubita della giustizia e dell'onnipotenza di Dio. Il suo secondo discorso è più misericordioso e umano; ha quasi raggiunto l'eresia, caratterizzando l'entità del male portato dalla peste. Ma allo stesso tempo non può rinunciare alla sua fede. L'autore attribuisce Padre Panel alla peste perché non ha raggiunto un accordo con se stesso nel comprendere l'unità dell'amore per il Signore e per una singola persona vivente. Ha scelto Dio ed è morto con un crocifisso tra le mani, sopportando coraggiosamente la sofferenza.
Un esempio interessante è la protesta contro l’epidemia di assurdità e malvagità nell’anima di un “piccolo uomo”, un impiegato minore dell’ufficio del sindaco, Joseph Gran. Per Camus incarnava due temi molto importanti: creatività e amore, sebbene entrambi acquisiscano un carattere assurdo. La moglie ha lasciato il povero perdente molti anni fa, l'unica frase del suo romanzo sull'Amazzonia del Bois de Boulogne è semplicemente “il suo lavoro” per lui, la sua salvezza, e non una vera opera d'arte. Tuttavia, nella squadra sanitaria è diventato il “cuore amministrativo”, alla guida statistiche terribili appestare Si possono considerare queste note secche e rigorose il vero capolavoro di Gran, che trovò la forza di resistere così potentemente alla peste, superando la malattia e sopravvivendo, nonostante a tutti gli effetti fosse lui a dover morire, e non gli uomini forti Tarrou e Panelu.
È importante che gli eroi di Camus facciano le loro scelte consapevolmente. L'idea della scelta morale è il nucleo di ciascuno dei personaggi del romanzo. Lo scrittore è meno interessato ai fatti biografici e ai tratti caratteriali dei suoi eroi. L'obiettivo principale di Camus è il loro credo esistenziale.
Secondo la logica, secondo le leggi dell'esistenza L’uomo è completamente incapace di sconfiggere la peste e il male. In fondo, le argomentazioni del dottor Rieux sull'immortalità del bacillo della peste sono più un avvertimento, un invito a vigilare, a non dimenticare mai che il pericolo è sempre vicino. E per quanto onnipotente sia la peste, il Male del mondo, la lotta di Rieux e dei suoi amici non sembra vuota, e questo ha dimostrato l’inesauribile umanesimo di Albert Camus, che ha tirato fuori il suo meglio romanzo esistenziale in una serie di opere rilevanti del nostro tempo. "Umanesimo tragico" La ribellione degli eroi di Camus sta nel fatto che, pur rendendosi conto dei limiti delle loro capacità nella lotta contro il male, non depongono le armi. Secondo il ricercatore S. Velikovsky, "The Plague" è, prima di tutto, un libro su coloro che resistono, e non su coloro che si arrendono, un libro sul significato dell'esistenza, che si trova nel caos della vita.
Trama del romanzoè basato sugli eventi dell'Anno della Peste ad Orano (Algeria), una terribile epidemia che spinse i cittadini nell'abisso della sofferenza e della morte. Ne parla Dottor Rieux- una persona che riconosce solo i fatti. Si impegna per l'accuratezza della sua presentazione, senza ricorrere ad alcuna decorazione artistica. Per natura, visione del mondo, natura delle attività, corso degli eventi, è guidato solo dalla ragione e dalla logica, non riconosce l'ambiguità, il caos, l'irrazionalità. Rie adempie al suo dovere di medico, aiuta i malati, rischia la propria vita, senza mai mettere in discussione il suo ruolo nella lotta contro una malattia specifica, contro il male in generale. Altri personaggi, come Tarru, si raccolgono intorno a lui. Per loro la peste e il male sono qualcosa di inseparabile dall'uomo, e anche chi non è malato porta ancora la malattia nel suo cuore. Persone buona volontà capaci di sconfiggere un male specifico, ma non possono distruggerlo come categoria dell'universo. E quindi, alla fine del romanzo, alle grida di gioia dei cittadini che celebrano la liberazione da terribile malattia, Il dottor Rie pensa che questa gioia sia temporanea, si rende conto che "... forse verrà il giorno in cui, nel dolore per le persone, la peste risveglierà i topi e li manderà a morire per le strade di una città felice".
"La Peste" - un romanzo di esistenzialismo. (La letteratura dell'esistenzialismo si concentra sull'individuo, sui problemi della sua esistenza e sui rapporti con il mondo. Di norma, i problemi dell'esistenza appaiono davanti a una persona in situazioni limitanti per la vita. Nel romanzo "La peste" c'è proprio una situazione del genere in cui ognuno risolve questo problema da solo. Gli eroi di Camus provano combatti l'assurdità della vita e fai la tua scelta.)
Problemi del romanzo.(L'opera tocca i problemi del significato della vita, della responsabilità umana per tutto ciò che accade. Il problema del bene e del male è considerato sia filosofico che specifico della situazione di Orano, dove si lotta non solo con la malattia, perché la data indica l'epoca della Seconda Guerra Mondiale e allude al fascismo.)
Tema e titolo del romanzo. (Il titolo stesso dell'opera riflette il tema: una storia sulla lotta delle persone contro la peste, quando ognuno decide da solo cosa farà. Insieme, il titolo del romanzo è simbolico, ha diversi significati: la peste è una malattia, la peste è un'allegoria del male che c'è in ognuno di noi (fino a un certo momento si nascondeva ed è meglio non toccarla. Inoltre, a quei tempi in Europa il fascismo veniva chiamato la peste bruna).
Genere.(Il romanzo è chiamato cronaca, cioè riflette fattivamente e accuratamente gli eventi in ordine cronologico. Ciò garantisce realismo, veridicità e obiettività della narrazione.)
Composizione. (Il romanzo è costruito sotto forma di monologo, poiché è questa forma che trasmette accuratamente lo stato di una persona che si ritrova sola con il mondo e i problemi (una caratteristica sorprendente dell'esistenzialismo). Esistono diversi monologhi, rappresentano diversi nazioni.Questa costruzione è dovuta all'idea di mostrare una persona che non piange, impotente di fronte al destino, ma che scrive un libro su persone che non abbaiano, ma sono capaci di lottare e cercare un significato in mezzo di sciocchezze ambiente Secondo il contenuto del volume, questo è un romanzo-parabola.)
Il contenuto dell'allegoria principale e idea nuova. (La peste è l'allegoria principale del romanzo di Camus. La peste è la personificazione non solo di una malattia fisica, ma anche di una malattia paneuropea: il fascismo. La peste è anche la personificazione del male, dormiente in tutti, ed è importante per non lasciarla sfuggire al controllo della nostra moralità. Usando la forma delle Cronache Camus ha creato un romanzo ammonitore in cui mette in guardia dal pericolo di perdere la moralità come garanzia dell'esistenza dell'umanità. È qui che vede la lezione principale della Guerra Mondiale II. L'uomo era ed è il centro dell'essere: questa è l'idea dell'esistenzialismo.)
Bernard Rieux - personaggio principale funziona, un medico locale, che è anche il narratore degli eventi accaduti nel romanzo. Rie combatte stoicamente l'epidemia di peste, nell'immagine della quale Camus ha mostrato ogni disastro naturale, cioè una manifestazione del Male universale. In effetti, combattere la peste è quasi senza speranza. Comprendendo questo con sobrietà, il dottor Rie non interrompe il suo lavoro per un secondo, rischiando la propria vita. Grazie alla logica e alla serietà del medico, vediamo immagine reale epidemie. Il dottor Rieux, a causa della sua professione, si è trovato più volte faccia a faccia con la morte. La morte del bambino, che ha risvegliato padre Panelu alla sua vera esistenza, è stata una dura prova per il dottor Rie. Sembrerebbe che le questioni ideologiche globali siano state da tempo risolte dal medico: non riconosce Dio non perché non esiste, ma perché non è necessario.
Padre Panelu. Inizialmente appare al lettore nella forma piuttosto ripugnante di un predicatore che quasi esulta per l'epidemia. In esso vede la punizione di Dio per i peccati degli Orani. Questa linea di pensiero, abbastanza tipica per il cristianesimo, indica che il sacerdote continua ad esistere per inerzia - non ha ancora cominciato a "essere". Panelu vuole sfruttare la paura dei suoi parrocchiani per rafforzare la loro fede indebolita e fiacca. Una grande prova per il padre gesuita è la propria malattia: accettare l'aiuto dei medici significa ammettere la debolezza e l'incoerenza delle proprie convinzioni. Il sacerdote, del resto, capisce perfettamente che questo aiuto non lo aiuterà a salvarsi. A giudicare dalla versione originale del romanzo, Camus condusse Panelu, ammalato di peste, a una catastrofe religiosa. Ma nella versione finale del romanzo, Panelu rimane fedele alla propria scelta.
Tra coloro che cercano di lasciare la città catturato dalla peste c'è l'unico personaggio con un nome, Rambert. Camus gli dà un nome per un solo motivo: non scappa. Non corre, nonostante sia uno sconosciuto in città, nonostante il fatto che la sua amata donna stia aspettando da qualche parte e Rambert crede sinceramente che dovrebbe essere accanto a lei. Il momento del risveglio dell'essenza umana per Rambert è un attacco di sospettosità, quando “all'improvviso immaginò che le ghiandole del suo inguine fossero gonfie e qualcosa sotto le sue braccia gli impedisse di muovere liberamente le braccia. Decise che era la peste."