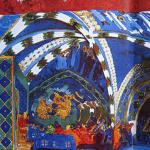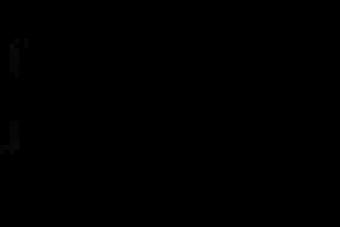- Natura, sei arrabbiata, gelosa di qualcosa?
- Da Vinci, che scrisse la stella terrestre,
Cecilia, il cui bellissimo sguardo brillava tanto,
Che è riuscito a eclissare la faccia del sole per un minuto.
A te solo va ogni onore, Natura; almeno come se
Sulla tela - tutto udito, labbra chiuse...
Sappi che ora è viva per sempre,
Ed è diventato un attributo eterno della tua gloria.
Per questo sia lode Il Moro. O ancora,
Si lodarono il talento e la mano di Leonardo,
Ti ha preservato per sempre per i posteri.
Bernardo Bellincione
Leonardo Da Vinci. Dama con l'ermellino. 1489-1490
Le donne in Polonia hanno sempre avuto una posizione speciale. Pertanto, il fatto che i polacchi abbiano “ottenuto” questo particolare capolavoro di Leonardo può essere visto come un segno del destino. "La Dama con l'ermellino." Cecilia Gallerani. Una giovane bellezza, un'intellettuale, esperta di arte, filosofia, che ne padroneggia diverse lingue straniere, futuro proprietario di uno dei salotti letterari più famosi d'Europa. (“Al tempo in cui la nobilissima e degnissima Signora Cecilia, Contessa Bergamini, beveva le acque minerali del Bagno d'Acquano per guarire i suoi disturbi, molti gentiluomini e dame la visitarono, un po' perché era cordiale e gentile, un po' per il fatto che in sua compagnia si potessero incontrare i migliori e menti eccezionali Milano, così come con gli stranieri che si trovavano qui. I capi militari parlavano qui di affari militari, i musicisti cantavano, i pittori e gli artisti dipingevano, i filosofi parlavano della natura e i poeti recitavano le proprie poesie e quelle di altri; in modo che i desideri di tutti coloro che volevano parlare o ascoltare degni giudizi fossero esauditi, poiché in presenza di questa eroina si discuteva sempre di cose molto piacevoli, virtuose e nobili. M. Bandello)
Ma questo accadrà in futuro, quando si sposerà, se non per comodità, almeno per il desiderio di ottenere un certo stato sociale e diventerà contessa Bergamini. E ora è l'amata del duca di Milano, Ludovico Sforza. Per ora condivide il potere con sua madre. Ma diventerà sicuramente l'unico sovrano. Cecilia gli darà un figlio, Cesare, che Sforzo adotta ufficialmente. E poi si separeranno. Ecco come andranno a finire le circostanze. Forse, cercando di dimenticarla, Ludovico troverà una sua sostituta e di lì a poco, nascondendo le sue origini non molto nobili, sposerà qualcun'altra. Sopravviverà a sua moglie e si addolorerà inconsolabilmente dopo averla persa. Durante le guerre d'Italia verrà catturato dai francesi e finirà i suoi giorni in prigione, affranto e avvilito.

G. Memling. Ritratto giovanotto. 1485-1490 È questo ritratto su Internet che è costantemente associato a Lodovico Sforza. Ma nelle "gallerie" dell'artista è semplice: "Ritratto di un giovane uomo"

Leonardo Da Vinci. La Belle Ferroniere raffigura presumibilmente Lucrezia Crivelli, la prossima favorita di Lodovico il Moro.

Ambrogio de Predis. Ritratto di Beatrice d'Este, moglie di Lodovico Sforzo, c. 1490

Lodovico Sforza. (Il Moro)

Lodovico Maria Sforzo. Pala Sforzesca, 1494 Brera, Milano.

Pala Sforzesca, 1494 Brera, Milano.
Ma tutto questo è anche nel futuro. Adesso Cecilia e Lodovico il Moro sono felici.
Il suo ritratto è dipinto dal fiorentino Leonardo da Vinci, invitato a Milano, principalmente come ingegnere e scultore. .

Gli esperti ritengono che un piccolo schizzo trovato recentemente nei diari di Leonardo da Vinci sia il suo primo autoritratto. Lo schizzo, che ha più di 500 anni, è stato nascosto agli occhi degli specialisti, poiché era visivamente cancellato ed è stato scoperto solo con l'ausilio di attrezzature speciali.
Il Castello Sforzo, dove viene dipinto il ritratto, è rumoroso e divertente. Leonardo è l'anima dell'incontro. Lui stesso è un meraviglioso conversatore, adora conversazioni interessanti. Il suo discorso è figurato, aforistico, spiritoso e pieno di enigmi inaspettati. Ma la giovane Cecilia non ha paura delle sorprese. È viva, coraggiosa e libera, come questo animale predatore tra le sue braccia. È forte e indipendente, non per niente la chiameranno “la nuova Saffo”. Solo per un secondo Cecilia pensa alla risposta. Hanno molto di cui parlare. Ad esempio, sulla musica. Entrambi suonano magnificamente il liuto. O sulla letteratura. Amano leggersi le proprie poesie.
Questi due non si perderanno una volta finite le sessioni. Leonardo le scriverà delle lettere. "L'incomparabile Donna Cecilia. Mia amata dea. Dopo aver letto le tue più tenere..." Cortese, nello spirito dei tempi, l'appello è colorato dall'ironia insita in entrambi. Ma il fatto che siano chiamati per nome in questo cerimoniale del XV secolo parla di vicinanza spirituale, sono "dello stesso sangue", uccelli dello stesso volo...
Forse è stata Cecilia, la sua bellezza e libertà, a incoraggiare Leonardo a utilizzare una nuova (vecchia e ben dimenticata) tecnica antica - contrapposto (anche se in tutta onestà, va detto che in questo periodo stava sperimentando molto con il così- chiamato “ritratto di spalla”, esplorando le possibilità plastiche corpo umano). Il suo amico poeta Bernardo Bellincione lo noterà:
“Nel ritratto della signora Cecilia Gallerani le spalle sono girate in modo tale che è del tutto chiaro quanto il loro movimento dipenda dalla posizione delle mani e dalla rotazione della testa. Se le spalle si muovono ulteriormente, anche la testa girerà, ma secondo la regola del contrapposto in il lato opposto. La mano della signora Cecilia, giovanile nelle proporzioni e nella magrezza, è piegata a mestolo e le falangi medie delle dita sono divaricate: il mestolo è racchiuso da un animale, aggrappato con timore al petto piatto della signora: una martora bianca, di quelle che viene tenuto nelle case per intrattenimento. L'immagine della martora è interpretata in due modi: come simbolo di verginità e come simbolo di potere. Qui il primo non c'entra, resta il secondo: la martora può diventare ermellino, e Lodovico Moro il duca di Milano"
A giudicare dalla lettera Cecilia Gallerani all'amica Isabella d'Estedatato 29 aprile 1498, il ritratto era di sua proprietà. Inoltre, le sue tracce sono perse, è possibile tracciare una storia affidabile Con fine XVII I secolo: nel 1798 (presumibilmente) la tela fu portata dall'Italia a Cracovia dal futuro ministro degli Esteri russo, il principe Adam Czartoryski.

I. I. Oleshkevich. Ritratto di A. Czartoryski.
Ha regalato il leggendario dipinto a sua madre, Izabella Czartoryska. Lo ha collocato nel museo che ha fondato nella sua tenuta Puławy anche in 1778

A.Roslin. Ritratto di Isabella Czartoryska, fondatrice della prima Museo d'Arte in Polonia.
Durante Rivolta polacca 1830 la proprietà Czartoryski fu confiscata Impero russo, ma Czartoryski inviò il dipinto a Parigi, ed era arrivato Hotel Lambert , dove visse il principe e fu ospitata la sua collezione.

Hotel Lambert. Palazzo del XVII secolo nel centro di Parigi, sull'Ile Saint Louis. Dal 1843 centro politico e culturale della diaspora degli emigranti polacchi in Francia, guidata dai fratelli Czartoryski. Il palazzo fu acquistato dalla moglie di Adam Jerzy Czartoryski dopo la sconfitta della rivolta del 1830 - 1831. Con il passare del tempo, soprattutto dopo la sconfitta della rivolta del 1863, l'Hotel Lambert perse il suo volto prettamente politico e divenne centro culturale Diaspora polacca. Si sono esibiti qui Balzac , Hector Berlioz, Adam Mickiewicz, Chopin .
Il nipote di Isabella, Vladislav, in fuga da Guerra franco-prussiana , lasciò la Francia e nel 1876 riportò la congregazione in Polonia, dove aprì a Cracovia Museo Czartoryski , di cui l'immagine è diventata parte.
Edificio del Museo Czartoryski - collezione d'arte nell'ambito di Museo Nazionale- ex arsenale di Cracovia.
Dopo che la Germania occupò la Polonia nel 1939 il dipinto fu portato via con l'obiettivo di inviarlo al Museo Hitler di Lincei inserito Museo di Berlino Kaiser Friedrich (oggi Museo Bode). Nel 1940, Hans Frank, governatore generale Polonia, ne ordinò il ritorno nella sua residenza a Cracovia. Alla fine della guerra, il dipinto fu scoperto da una commissione polacco-americana nella casa di Frank a Baviera e nel 1946 tornò in Polonia.
- Anno di creazione: 1483-1490
- Tecnica pittorica: e su tavola
- Genere pittorico: ritratto
- Stile: pittura rinascimentale
- Mostra: Castello reale di Wawel a Cracovia
Il dipinto "La Dama con l'ermellino" (conosciuto come "La Dama con l'ermellino") è stato realizzato nell'arco di 7 anni a Milano. L'autore di questa immagine è Artista italiano Rinascimento - Leonardo da Vinci.
Il dipinto raffigura con in mano un ermellino, che in precedenza si pensava fosse una donnola o un furetto. Questo animale ha significato simbolico, perché il suo nome in greco significa “GALE”, che è legato anche al nome della modella - Gallerani Cecilia, l'amante di Lodovico Sforza, sul cui stemma di famiglia è disegnato un ermellino. Sfortunatamente, nel processo di creazione di quest'opera, Leonardo da Vinci non ha potuto dipingere Cecilia e Luigi in un abbraccio amorevole perché Cecilia era già fidanzata con Beatrice d'Este. L'animale riposato tra le braccia della ragazza è una rappresentazione simbolica della situazione. Potrebbe mostrare la gravidanza della Gallerani, che presto partorirà figlio illegittimo Sforzie – Cesare.
Questo ritratto allegorico è stato realizzato utilizzando la tecnica della miscelazione dell'olio con la tempera. Una ricerca condotta nel 1992 ha dimostrato che sotto lo sfondo nero di quest'opera si trova un disegno originale grigio-blu, che probabilmente non poteva trasmettere tutta l'abilità dell'artista rinascimentale. Il significativo oscuramento dello sfondo conferisce al dipinto “Dama con l’ermellino” l’effetto di profondità del personaggio.
SU primo piano puoi vedere i giovani bella donna con uno luminoso, rivolto a noi a tre quarti. Il suo colore scuro, la sua fronte è cinta da una cintura sottile, che viene tirata dolcemente indietro. Anche i capelli sono ricoperti da un velo trasparente. I bellissimi grandi grigi sono rivolti a sinistra mentre il corpo è inclinato nella direzione opposta. Sul sottile collo di alabastro sono presenti coralli neri. La donna è vestita con un abito di velluto colorato con spacco, maniche ampie e profonda scollatura. Tra le sue braccia c'è un piccolo animale beige chiaro. L'ermellino alza la testa e guarda anche lui a sinistra. L'immagine di sfondo è troppo scura per vedere qualcosa. Il chiaroscuro evidenzia sapientemente tutte le curve del corpo della ragazza Gallerani e dell'ermellino.
Nel 1800, la “Dama con l'ermellino” fu donata al principe Czartoryski per sua madre Isabela. A quel tempo non si conosceva ancora la vera storia della modella che posò per il ritratto. La storia di quest'opera divenne nota solo nel XX secolo, grazie al quale oggi conosciamo l'interpretazione più probabile de “La Dama con l'ermellino”. Questa immagine era originariamente esposta nella Casa Gotica a Puławy. Durante la rivolta di novembre, il dipinto fu portato a Parigi. Nel 1880 arrivò a Cracovia al Museo Czartoryski. Durante la seconda guerra mondiale, il dipinto di Leonardo fu saccheggiato dai nazisti, ma tornò in Polonia nel 1946.
Oggi la "Dama con l'ermellino" si trova sul Wawel a Cracovia. Questo l'unica immagine Leonardo da Vinci in Polonia.
A Cracovia, nel Museo Czartoryski, c'è un dipinto che ne costituisce il soggetto orgoglio nazionale Poli: un dipinto presumibilmente di Leonardo da Vinci - “La Dama con l'ermellino” (Dama con l'ermellino).
Insieme alla “Gioconda”, al “Ritratto di Ginevra de Benci” e alla “Bella Ferronera”, il dipinto è classificato come numero quattro ritratti di donne pennelli di Leonardo.
Si ritiene che il ritratto sia stato dipinto nel 1489-1490. Secondo molti ricercatori si tratta del ritratto della diciassettenne Cecilia Gallerani, amante di Lodovico Sforza, soprannominato Il Moro, duca di Milano. Ma esistono altre versioni con altre date e con altre versioni delle eroine.
Paternità
Il dipinto mostra un alto livello di artigianalità, ma il ritratto è pesantemente riscritto, il che non ci permette di affermare con assoluta certezza che il suo autore sia Leonardo. La paternità è stata attribuita anche a Marco d'Oggiono, Ambrogio di Predis, Boltraffio.
Restauro e modifiche
Un esame radiografico del dipinto ha dimostrato che era stato copiato. Il suo sfondo è stato reso più scuro (forse in origine era blu scuro) e la porta (finestra) situata in alto a destra (dietro la spalla sinistra della donna) è stata rimossa. Lo sfondo è stato reso più scuro durante il restauro del dipinto tra il 1830 e il 1870. Si presume che ciò avrebbe potuto essere fatto dall'artista Eugene Delacroix.
Nell'immagine originale, la testa della donna era ornata da un velo trasparente, ritoccato con dei capelli. Il ponte del naso e l'attaccatura dei capelli sono stati modificati. La posizione delle due dita inferiori su mano destra sono anche alterati e sembrano meno naturali di altri.
Iscrizione "LA BELE FERONIERE LEONARD D'AWINCI" nell'angolo in alto a sinistra è stato realizzato successivamente e non da Leonardo - si presume sia stato realizzato nel inizio XIX secolo dopo l'acquisto del dipinto da parte di Czartoryski, il quale ipotizzò che questo ritratto fosse la stessa donna della “Bella Ferronière” del Louvre. In ogni caso l'iscrizione non è stata fatta in Italia, poiché lì avrebbero scritto il nome Leonard con una “O” finale e non avrebbero usato una “W”.
La radiografia ha evidenziato tracce della tecnica dello spolvero anche sui contorni della figura e della testa, il che conferma l'utilizzo del “cartone” - il disegno originale, che veniva trasferito su tavola mediante sovrapposizione e pittura sopra. Le impronte digitali, che di solito si trovano nei dipinti di Leonardo di questo periodo (ha leggermente imbrattato la vernice), sono state identificate anche sul viso di Cecilia e sulla testa dell'animale. Le radiografie hanno mostrato che Leonardo inizialmente voleva circondare la figura con un arco o una finestra semicircolare, ma poi ha cambiato idea.
In realtà, riguardo al ritratto.
K. Pedretti scrive: “Forse di più bella immagine Leonardo Da Vinci. La base è l'originalità della posa, luminosa espressività, che sembra stabilire un rapporto simbolico tra il volto aristocratico della donna e il segno araldico dell'animale. Con questo dipinto Leonardo da Vinci dà inizio alla tradizione dei ritratti quattrocenteschi: non è più rappresentato il profilo della modella, come su una medaglia, ma un'immagine di tre quarti, tipica dei busti. C'è una naturalezza, una fissazione di un momento, simile ai fotogrammi di un film." "Nel ritratto della signora Cecilia Gallerani, le spalle sono girate in modo tale che è del tutto chiaro quanto il loro movimento dipenda dalla posizione delle mani e rotazione della testa. Se le spalle si muovono ulteriormente, anche la testa girerà, ma secondo la regola del contrapposto nella direzione opposta. La mano della signora Cecilia, giovanile nelle proporzioni e nella magrezza, è piegata a mestolo e le falangi medie delle dita sono divaricate: il mestolo è racchiuso da un animale, aggrappato con timore al petto piatto della signora: una martora bianca, di quelle che viene tenuto nelle case per intrattenimento. L'immagine della martora è interpretata in due modi: come simbolo di verginità e come simbolo di potere. La prima qui non c'entra, la seconda resta: la martora può diventare ermellino, e Lodovico Moro il duca di Milano." (Da "Life persone meravigliose" Gasteeva A.A.)
A proposito, l'ermellino era considerato un simbolo di purezza e castità e, secondo la leggenda, moriva se la sua pelle si sporcava e si perdeva. Colore bianco.
Nelle fonti scritte il dipinto è menzionato già dalla fine del XVII secolo: presumibilmente nel 1798 il dipinto fu portato dall'Italia a Cracovia dal principe polacco Adam Czartoryski, che lo regalò a sua madre Isabella. Collocò il dipinto anche nel museo da lei fondato nella sua tenuta di Puławy nel 1802.
Poi l'immagine ha viaggiato un po'. Così, durante la rivolta polacca del 1830, Czartoryski inviò il dipinto a Parigi, dove fu conservato nell'Hotel Lambert insieme al resto della collezione del principe (la proprietà principale dei Czartoryski fu confiscata dall'Impero russo). Il nipote di Isabella, Władysław, in fuga dalla guerra franco-prussiana, lasciò la Francia e restituì la collezione in Polonia nel 1876, dove aprì il Museo Czartoryski a Cracovia, dove ospitò “La Dama con l’ermellino”.
Durante la prima guerra mondiale la tela fu inviata a Galleria di Dresda per sicurezza, prima della seconda guerra mondiale venne nuovamente nascosto, ma nel settembre del 1939 cadde ancora nelle mani dei nazisti. Quindi, nella Polonia occupata dai tedeschi, lo avrebbero inviato al Museo Hitler di Linz, lo avrebbero collocato temporaneamente nel Museo Kaiser Friedrich a Brelino e nel 1940 il governatore generale della Polonia ordinò che fosse restituito a Cracovia, alla sua residenza. E alla fine della guerra, la "Dama con l'ermellino" fu scoperta da una commissione polacco-americana nella casa di Frank in Baviera e fu restituita alla Polonia nel 1946.
Nel dicembre 2016 il governo polacco ha acquistato per 100 milioni di dollari l’intera collezione Czartoryski (86mila opere d’arte, una biblioteca di 25mila libri e manoscritti, oltre a diversi edifici a Cracovia), compreso un dipinto di Leonardo.
Leonardo Da Vinci. Dama con l'ermellino , 1489–1490 Olio su tavola 54×40 cm Museo Czartoryski, Cracovia
Si ritiene che il dipinto sia di Leonardo da Vinci. Secondo molti ricercatori si tratta del ritratto di Cecilia Gallerani, l'amante di Lodovico Sforza, soprannominato Il Moro, duca di Milano, che trova conferma nel complesso simbolismo del dipinto.
Insieme alla Gioconda, al Ritratto di Ginevra de Benci e alla Belle Ferronière, il dipinto è uno dei quattro ritratti femminili di Leonardo.
CHI È CECILIA GALLERANI?
Cecilia è nata a Siena nel grande famiglia. Suo padre Fazio non era un nobile, ma ricoprì diversi incarichi alla corte milanese, tra cui l'incarico di ambasciatore a Firenze. Insieme ai suoi fratelli, Cecilia ha studiato lingua latina e letteratura.

Nel 1483, all'età di dieci anni, si fidanzò con Stefano Visconti, ma il fidanzamento venne interrotto nel 1487 per ragioni sconosciute. Nel maggio 1489 lasciò casa per il monastero Nuovo, e forse fu lì che conobbe il Duca. Il 3 maggio 1491 diede alla luce il figlio Cesare (Cesare Sforza Visconti), nello stesso anno sposò la nobile Beatrice d'Este che, dopo il matrimonio di Lodovico, continuò a vivere nel suo castello per qualche tempo, anche se ormai Lucrezia Crivelli era già diventata la sua nuova favorita.
Ma poi la nuova duchessa venne a sapere della madre del bastardo, e Lodovico dovette lasciarla: “Beatrice, appena sposata e venuta a conoscenza di questa relazione con il duca, era gelosa di lui, minacciò di tornare a casa di lei padre, il duca di Ferrara, Ercole d'Este e Moreau fu costretto “giurò solennemente, alla presenza degli ambasciatori, di non violare la fedeltà coniugale, a conferma di ciò sposò Cecilia al vecchio e fallito conte Bergamini, un uomo accomodante uomo, pronto per ogni tipo di servizio”.

Eccolo questo famoso amante. Ludovico SFORZA, Pala degli Sforza, 1494. Brera, Milano
Merezhkovsky D.S. nel suo libro menziona l'amicizia di Cecilia e Lucrezia Crivelli dopo la morte della duchessa Beatrice: secondo lui, dopo la morte della moglie, Lodovico si affezionò ancora di più alle sue amanti. Cecilia (che, nonostante la sua cultura, era “semplice e donna gentile, anche se alquanto entusiasta") convinse l'ex rivale a diventare amici e consolare insieme il Duca.
Quando Lucrezia ebbe un figlio da Moreau, la contessa volle farle da madrina e «con esagerata tenerezza cominciò ad allattare il bambino, 'suo nipote', come lo chiamava lei». Lodovico era così felice strana amicizia e commissionò un sonetto al poeta di corte. In esso “Cecilia e Lucrezia venivano paragonate all’alba della sera e del mattino, e lui stesso, vedovo inconsolabile, tra le due dee radiose, con in una notte buia, per sempre lontano dal sole, - con Beatrice"
Cecilia era una donna dotata ed istruita, parlava fluentemente il latino, cantava magnificamente, suonava musica e scriveva poesie in diverse lingue e si distingueva per il suo ingegno.

Nel 1492, dopo il matrimonio con Ludovico di Brambilla, conte di Bergamino, le fu donato il Palazzo di Carmagnola. Diede alla luce marito di quattro figli bambini. Dopo la morte del marito e del figlio Cesare nel 1514-1515, si trasferì nella zona del castello di Cremona. San Giovanni in Croce

Castello di San Giovanni in Croce.
Bandello la descrive come mecenate delle arti; secondo altre prove il suo salone fu il primo in Europa. Mantenne un salone finché i francesi non confiscarono le terre di Saronno e Pavia, concesse al figlio bastardo dal padre, e dovette partire per Mantova. Riuscì a ripristinare la sua prosperità quando gli Sforza tornarono al potere. Come la maggior parte delle donne istruite del suo tempo, Cecilia si occupava di cultura solo per il proprio piacere. Non ha mai pubblicato poesie o testi scritti da lei.
Morì all'età di 63 anni e fu probabilmente sepolta nella cappella della famiglia Carminati nella Chiesa di San Zavedro.
CECILIA E LEONARDO.
Cecilia incontrò Leonardo al Castello Sforzesco e si ritiene che nel 1489 iniziò a dipingere il suo ritratto. Lo invitò a convegni di intellettuali milanesi dove si discuteva di filosofia e di altre scienze; Cecilia ha presieduto personalmente questi incontri.

Leonardo Da Vinci. Disegno del profilo di Cecilia Gallerani
Leonardo ha conservato la bozza di una lettera, presumibilmente indirizzata a Cecilia, che iniziava così: "La mia amata dea..."; è noto anche che usavano il “tu” tra di loro, anche se in quell'epoca anche gli amici e i parenti stretti si chiamavano “tu”. In base a questi fatti (oltre che alla connotazione sessuale, secondo molti, presente nel dipinto "Dama con l'ermellino"), alcuni ricercatori sono propensi a considerare la loro relazione intima. Tuttavia, il fatto che sia lei a essere raffigurata nel ritratto non è stato dimostrato in modo affidabile.
DESCRIZIONE DELL'IMMAGINE.
Nel ritratto vediamo una ragazza fragile con un leggero sorriso e uno sguardo pieno di sentimento. Tiene tra le braccia un animale bianco, premendolo con dita sottili e mobili. Una cuffia trasparente, fissata sotto il mento, sottolinea la tenerezza dell'ovale del viso.
Una semplice collana di perle scure, che borda il collo e scende in un secondo ovale fino al petto, dove è appena visibile sullo sfondo della scollatura quadrata dell'abito, è l'unica decorazione del ritratto.
Sul volto risaltano due grandi occhi dallo sguardo attento, un naso dritto e cesellato, una bocca piccola con labbra sottili appena sfiorate da un sorriso agli angoli. Bellissima anche l'interpretazione della pelliccia dell'animale, raffigurato con la zampa tesa; il colore bianco del suo manto lo identifica con l'ermellino invernale, simbolo di purezza. 
La fronte della ragazza è intercettata da un sottile feroniere, e in testa ha un berretto trasparente, assicurato sotto il mento. Al collo porta una collana di perle scure, che le borda il collo e scende in un secondo, lungo anello sul petto, dove si perde visivamente sullo sfondo della scollatura quadrata del vestito.
Cecilia Gallerani è raffigurata mezzo girata, il che, nonostante la forte inclinazione della testa verso la spalla sinistra, sembra molto naturale. Questa impressione è completata dai lineamenti morbidi e delicati di un viso immaturo, incorniciato da capelli dolcemente adagiati sotto il mento. La severità dell’acconciatura e lo sguardo distolto dallo spettatore creano la sensazione di un’immagine fioca e sobria; nell’aspetto di Cecilia si avverte una sorta di incompletezza, che le conferisce un fascino particolare.

Ermellino era considerato simbolo di purezza e castità e, secondo la leggenda, moriva se la sua pelle si sporcava e perdeva il colore bianco.
Secondo K. Pedretti: “Forse il più bel dipinto di Leonardo da Vinci. La base è l'originalità della posa, la brillante espressività, che
come se si stabilisse un rapporto simbolico tra il volto aristocratico di una donna e il segno araldico dell'animale. Con questo dipinto Leonardo da Vinci dà inizio alla tradizione dei ritratti quattrocenteschi: non è più rappresentato il profilo della modella, come su una medaglia, ma un'immagine di tre quarti, tipica dei busti. C'è una naturalezza in questo, la cattura di un momento, simile ai fotogrammi di un cinema."
UNA STORIA DEL FOTO COMPLETAMENTE INSOLITA.
Durante la prima guerra mondiale il dipinto fu inviato per sicurezza alla Galleria di Dresda. Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale fu nuovamente nascosto, ma nel settembre 1939 cadde nelle mani dei nazisti.
Dopo l'occupazione tedesca della Polonia nel 1939, il dipinto fu portato via per essere inviato al Museo Hitler di Linz e collocato nel Museo di Berlino Museo Kaiser Friedrich(ora Museo Bode). Nel 1940 Hans Frank, governatore generale della Polonia, ordinò il suo ritorno nella sua residenza a Cracovia. Alla fine della guerra fu scoperto da una commissione polacco-americana nella casa di Frank in Baviera e restituito alla Polonia nel 1946.
Il dipinto è l'unica opera di Leonardo in Polonia ed è motivo di orgoglio nazionale.
Possibile modello ritratto
Si ritiene tradizionalmente che la modella fosse l'amante del duca di Milano, Cecilia Gallerani. In precedenza, esisteva una versione in cui la stessa donna era raffigurata in un altro ritratto di Leonardo - "Bella Ferroniere", sebbene in attualmente si ipotizza che interpreti la prossima amante del Duca, Lucrezia Crivelli.
L'identificazione di questo ritratto con un'immagine del Gallerani risale all'epoca moderna. Già nel 1877 gli studiosi dell'opera di Leonardo scrivevano: “di questo ritratto, glorificato dai poeti, restano solo alcune copie controverse e un sonetto di Bellincioni. È indicato che il ritratto originale della bella Cecilia era nel XVIII secolo in possesso del marchese di Boursane a Milano. Ma dov'è adesso? In precedenza, una sua copia antica si trovava nella Biblioteca Ambrosiana; e nella Pinacoteca di Monaco c'è una “Santa Cecilia”, già posseduta dal professor Franchi e proveniente da una copia di un'allieva di Leonardo, della pessima Cecilia Gallerani. Esiste anche un secondo ritratto originale di Cecilia, situato presso la famiglia Pallavicini a San Calocero, dipinto all'apice della sua fama."
Storia e data di creazione
Si presume che Leonardo, che lavorò alla corte milanese, dipinse il ritratto quando Cecilia divenne l'amante del Duca – a partire dal 1489-1490. È consuetudine in letteratura indicare che il ritratto raffigura Cecilia, 17 anni, cosa che, tuttavia, non può essere dimostrata. D'altra parte, c'è una datazione risalente a primo periodo la sua opera a Milano, - 1482-1483. In questo caso il ritratto non raffigura Cecilia, poiché all'epoca aveva circa 10 anni. Secondo altre indicazioni: "Il ritratto fu dipinto dopo il 1487, come indica l'acconciatura di Cecilia alla spagnola introdotta a Milano da Isabella d'Aragona", è nota la data del suo matrimonio con il nipote Lodovico Sforza.
Sonetto XLV
Al ritratto di Madonna Cecilia,
scritto da Leonardo
– Natura, sei arrabbiata, gelosa di qualcosa?
- Da Vinci, che scrisse la stella terrestre,
Cecilia, il cui bellissimo sguardo brillava tanto,
Che è riuscito a eclissare la faccia del sole per un minuto.
– A te sola va ogni onore, Natura; almeno come se
Sulla tela - tutto l'udito, le labbra chiuse...
Sappi che ora è viva per sempre,
Ed è diventato un attributo eterno della tua gloria.
Per questo sia lode Il Moro. O ancora,
Si lodarono il talento e la mano di Leonardo,
Ti ha preservato per sempre per i posteri.
Quando le persone vedranno il ritratto, diranno che è un sogno,
Ciò che è stato dato loro ora come dono,
Un esempio accattivante della natura dei miracoli.
Ci sono informazioni indirette sulla conoscenza di Cecilia con Leonardo. Lo incontrò al Castello Sforzesco e si ritiene che nel 1489 iniziò a dipingere il suo ritratto. Lo invitò a convegni di intellettuali milanesi dove si discuteva di filosofia e di altre scienze; Cecilia ha presieduto personalmente questi incontri.
Leonardo ha conservato la bozza di una lettera, presumibilmente indirizzata a Cecilia, che iniziava così: "La mia amata dea..." (amantissima mia diva). Ci sono ipotesi su una relazione intima tra Leonardo e Cecilia, ma sono poco fondate, dal momento che una tale sillaba non era caratteristica distintiva corrispondenza d'amore, e prove attendibili Non ci sono informazioni sull'interesse di Leonardo per le donne.
Cecilia risponde che il ritratto non somiglia più all'originale, poiché è stato dipinto quando lei era ancora molto giovane, e da allora il suo aspetto è completamente cambiato ( per esser fatto esso ritratto in una eta sm imperfecta che io ho poi cambiata tutta quella effigie) (Scrive "sono passati 15 anni", che colloca la data nel 1483, quando in realtà aveva 10 anni.) Il ritratto è stato inviato a Isabella.
Autorevolezza e sicurezza
Leonardo da Vinci, cosiddetto "Bella principessa": presumibilmente raffigura Bianca Sforza, figlia illegittima Lodovico Sforza da un'altra amante, Bernardina de Corradis. OK. 1496 (?). La ragazza è vestita allo stesso modo, con una ferronière e un abito con maniche a spaccoIl dipinto è stato pesantemente riscritto, il che non ci permette di affermare con assoluta certezza che il suo autore sia Leonardo. Tuttavia, buone condizioni La conservazione di quelle parti del dipinto che raffigurano il volto della ragazza e la figura dell'ermellino rivela un'elevata maestria artigianale.
Oltre a Leonardo, l'opera era stata precedentemente attribuita a ad artisti diversi: Marco d'Oggiono, Boltraffio, Ambrogio di Predisu.
Un esame radiografico del dipinto rivelò che era stato copiato. Il suo sfondo è diventato più scuro (potrebbe essere stato originariamente blu scuro) e la porta (finestra) che si trovava in alto a destra (dietro la spalla sinistra) è stata rimossa. Lo sfondo è stato registrato durante la riparazione del dipinto tra il 1830 e il 1870, si ritiene che ciò possa essere stato fatto da Eugene Delacroix.
Nell'immagine originale, la testa della donna era ornata da un velo trasparente, ritoccato con dei capelli. Il ponte del naso e l'attaccatura dei capelli sono stati modificati. Anche la posizione delle due dita inferiori della mano destra è cambiata e sembrano meno naturali delle altre. Iscrizione "LA BELE FERONIERE LEONARD D'AWINCI" nell'angolo in alto a sinistra è stato realizzato più tardi e non dalla mano di Leonardo - si presume che all'inizio del XIX secolo dopo l'acquisto del dipinto da parte di Czartoryski, poiché supponeva che in questo dipinto ci fosse la stessa donna del “Bello Ferroniere” del Louvre. In ogni caso l'iscrizione non è stata fatta in Italia, poiché lì avrebbero scritto il nome Leonard con una "O" finale e non avrebbero usato una "W".
Lo studio ha trovato tracce di tecnologia spolverare sui contorni della figura e della testa, il che conferma l'uso del “cartone” - il disegno originale, che è stato trasferito sul tavolo da disegno mediante sovrapposizione e disegno sopra. Le impronte digitali, che di solito si trovano nei dipinti di Leonardo di questo periodo (ha leggermente sbavato il colore), sono state identificate anche sul viso di Cecilia e sulla testa dell'animale. Le radiografie hanno mostrato che Leonardo inizialmente voleva circondare la figura con un arco o una finestra semicircolare, ma poi ha cambiato idea.
Descrizione del dipinto e del suo simbolismo
La fronte della ragazza è ricoperta da un sottile feronniere e in testa ha un berretto trasparente, fissato sotto il mento. Al collo porta una collana di perle scure, che le borda il collo e scende in un secondo, lungo anello sul petto, dove si perde visivamente sullo sfondo della scollatura quadrata del vestito.
Cecilia Gallerani è raffigurata girando leggermente la testa di lato, il che, nonostante la forte inclinazione della testa verso la spalla sinistra, sembra molto naturale. Questa impressione è completata dai lineamenti morbidi e delicati di un viso immaturo, incorniciato da capelli dolcemente adagiati sotto il mento. La severità dell’acconciatura e lo sguardo distolto dallo spettatore creano la sensazione di un’immagine fioca e sobria; nell’aspetto di Cecilia si avverte una sorta di incompletezza, che le conferisce un fascino particolare.
Nel ritratto Cecilia si gira a sinistra, come se ascoltasse qualcuno invisibile (lo notò per la prima volta il poeta Bernardo Bellincione). Questo ritratto di tre quarti fu una delle invenzioni di Leonardo.
| “Nel ritratto della signora Cecilia Gallerani le spalle sono girate in modo tale che è del tutto chiaro quanto il loro movimento dipenda dalla posizione delle mani e dalla rotazione della testa. Se le spalle si muovono ulteriormente, anche la testa girerà, ma secondo la regola del contrapposto nella direzione opposta. La mano della signora Cecilia, giovanile nelle proporzioni e nella magrezza, è piegata a mestolo e le falangi medie delle dita sono divaricate: il mestolo è racchiuso da un animale, aggrappato con timore al petto piatto della signora: una martora bianca, il tipo che viene tenuto nelle case per motivi di intrattenimento. L'immagine della martora è interpretata in due modi: come simbolo di verginità e come simbolo di potere. La prima non c'entra qui, resta la seconda: la martora può diventare ermellino, e Lodovico Moro il duca di Milano." |
Secondo K. Pedretti: “Forse il più bel dipinto di Leonardo da Vinci. La base è l'originalità della posa, luminosa espressività, che sembra stabilire un rapporto simbolico tra il volto aristocratico della donna e il segno araldico dell'animale. Con questo dipinto Leonardo da Vinci dà inizio alla tradizione dei ritratti quattrocenteschi: non è più rappresentato il profilo della modella, come su una medaglia, ma un'immagine di tre quarti, tipica dei busti. C’è una naturalezza in questo, una fissazione di un momento, simile ai fotogrammi di un cinematografo”.
Esiste una versione, sostenuta tra gli altri da Wilhelm von Bode, secondo cui il dipinto raffigura non un ermellino, ma un furetto domestico bianco.
Storia della tela in epoca moderna
Affidabile storia scritta Questo dipinto può essere fatto risalire alla fine del XVIII secolo: nel 1798 (presumibilmente) la tela fu portata dall'Italia a Cracovia dal futuro ministro degli Esteri russo, il principe Adam Czartoryski. Sua madre Isabella, alla quale donò il dipinto, collocò il dipinto nel museo da lei fondato nella sua tenuta di Puławy nel 1802.
Il dipinto è l'unica opera di Leonardo in Polonia ed è motivo di orgoglio nazionale. Film "All-in 3" (polacco. Vinci) è dedicato alla storia immaginaria del suo furto, così come alla nobiltà di un truffatore che non può accettare di rubare un simile tesoro dalla sua terra natale.
Appunti
Commenti
Fonti
- Leonardo Da Vinci Trattato della pittura di Leonardo Da Vinci. - Kessinger Publishing (ristampa dell'edizione del 1877), 2004. - P. 226. - 340 p. -ISBN 9781417948352
- Mikhailov, B.P. Architetto Leonardo da Vinci. - M.: Casa editrice statale di letteratura sull'edilizia e l'architettura, 1952.
- Traduzione di Sofia Ponomareva
- Leone Calvin Rosten La storia dietro il dipinto. - Cowles Magazines e distribuzione commerciale di libri a cura di Doubleday, Garden City, 1962. - P. 32. - 165 p.
- Gastev, A.A. Capitolo 16 // Leonardo da Vinci. - M.: Young Guard, 1982. - (Vita di persone meravigliose).
- Gaia Servadio Donna del Rinascimento. - I.B.Tauris, 2005. - P. 52. - 274 p. -ISBN 9781850434214
- Cecilia Gallerani: La Dama con l'ermellino di Leonardo, di Janice Shell e Grazioso Sironi
- Gallerie domestiche italiane Dama con l'ermellino: CONSERVAZIONE ED ESAMI SCIENTIFICI (inglese). Archiviata dall' url originale il 28 gennaio 2012. Estratto il 13 dicembre 2011.
- Ritratto di Cecilia Gallerani (La Dama con l'ermellino) 1490. Università delle Arti, Londra. Archiviato
- Dama con l'ermellino. BBC (2006). URL consultato il 20 ottobre 2011 (archiviata dall' url originale il 28 gennaio 2012).
- DK Samin Leonardo da Vinci // Cento grandi artisti. - Veche, 2005. - ISBN 5-9533-0862-0
- Grashchenkov V. N. Ritratto in Pittura italiana Primo Rinascimento. M., 1996. P. 237